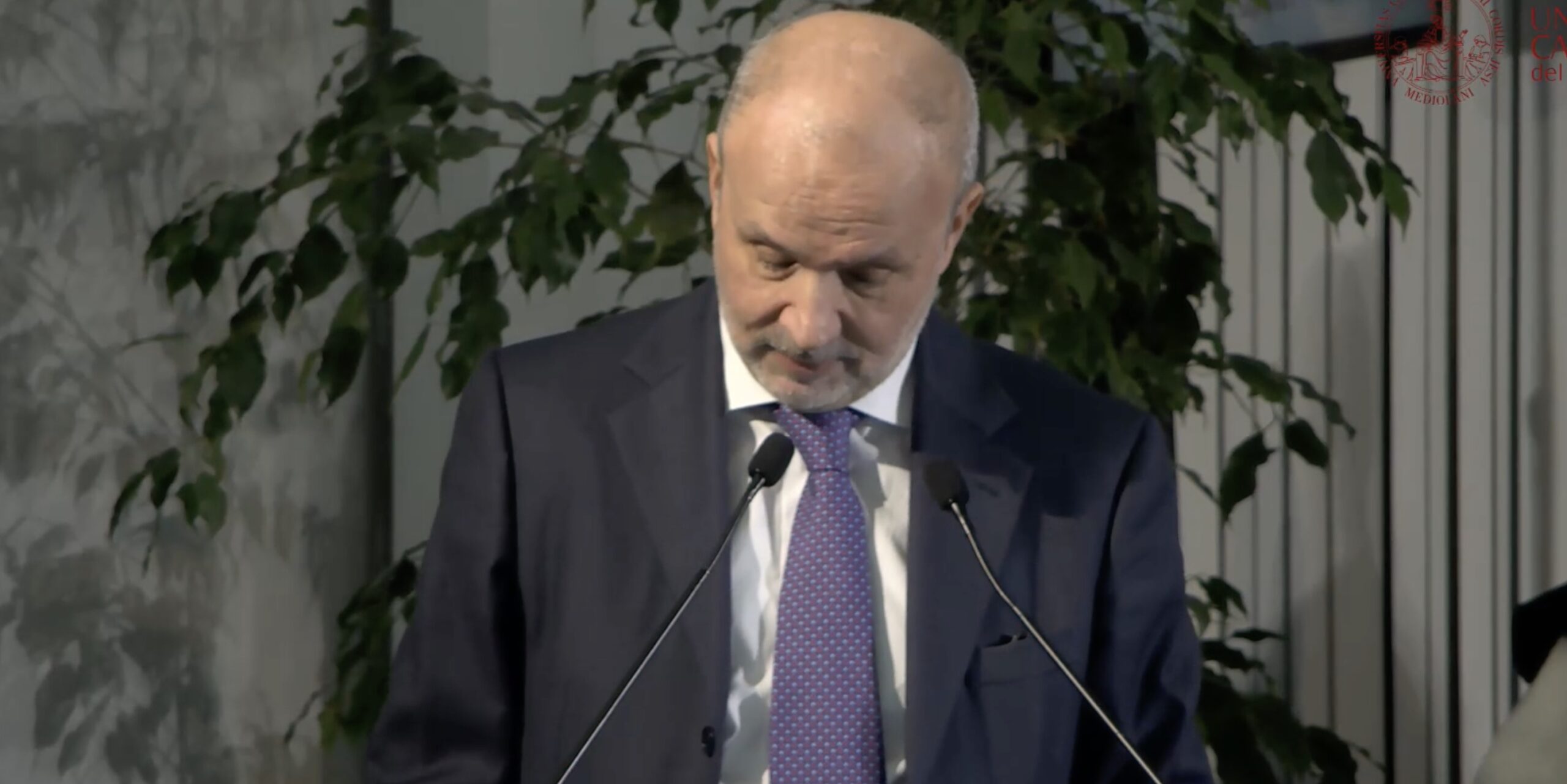Gentile Direttore,
primi anni ottanta: si studiava Medicina in maniera diversa, non c’erano il computer e tutto l’apporto informatico alla didattica, avevamo le lavagne con il polveroso gessetto, libri di testo e le immancabili dispense riassuntive compilate da solerti studenti sulla base di appunti presi a lezione, e professori.
A Chieti, i nostri erano soprattutto clinici: medici ospedalieri che insegnavano la loro esperienza al letto del malato. L’impostazione didattica, in quegli anni, era preminentemente clinica, fin dai primi anni di Università, anche le materie propedeutiche come Chimica o Fisica Biomedica avevano sempre un risvolto clinico. La domanda ossessiva che circolava nel nostro ambito accademico era: non cosa sapere, ma cosa saper fare. Il “saper fare” era il nostro demone quotidiano che ci ossessionava più dell’esame in sè. L’incubo notturno e diurno aveva questo aspetto fondamentale: se mi capita questo paziente, cosa devo fare? Era una continua corsa ad accaparrarsi quel sapere operativo che ci identificava come clinici, innanzitutto.
Ogni occasione era buona per infiltrarsi nelle corsie ospedaliere e spiare i nostri cattedratici all’opera. Diventavano indispensabili il contatto, la relazione, lo studio del paziente, la sua fisionomia, il suo agire, le sue risposte. Avevamo capito benissimo che fare il medico non significa partire dalla conoscenza della malattia per arrivare ai sintomi del paziente, come da studio della Patologia Medica, ma esattamente il contrario: partire dai sintomi e segni del paziente per arrivare alla malattia: la clinica. Quello che si fa con lo studio della Clinica Medica, ma bisogna avere ottima teoria e occhi molto attenti. La scienza dei segni: la semeiotica fisica aveva ancora un grande peso nei miei studi di allora.
Oggi, da medico di base, professione che svolgo da più di trenta anni, il mio metodo rimane clinico e, per certi versi, con quella impostazione ereditata dai miei maestri all’Università, nel concetto e nell’approccio al paziente. Ma c’è un cambio di passo che vedo frequentando i miei giovani colleghi e i reparti in cui operano: oggi c’è il computer con i suoi algoritmi e con un metodo procedurale spiccatamente tecnologico: esami, immagini, protocolli, standard clinici, procedure informatizzate, trials clinici che individuano percorsi operativi e linee guida. Tutto a portata di mano, bello, efficace utile, ma distante da quella dimensione spiccatamente umana del mestiere di medico: l’approccio relazionale con il paziente. Guardare, toccare, parlare, ascoltare, cogliere le proprie sensazioni e quelle del paziente e fare di tutto questo un quadro clinico personale e unico della persona, non secondo algoritmi informatici, ma secondo percezione umana. C’è stato un passaggio tecnico-culturale in questi anni, il computer era al nostro servizio, era un mezzo. Ora siamo noi a servizio del computer, stiamo diventando un suo strumento. Qual è la direzione intrapresa dall’Intelligenza Artificiale se non questa: raccogliere il nostro sapere per implementare la sua e fino a che punto? Spero che non si appropri mai del nostro intuito: la capacità esclusivamente umana di collegare connessioni apparentemente irrazionali, dal caso A a quello C senza passare per B.
Sarebbe una grazia divina per la Sanità ministeriale: un medico-bancomat del tutto virtuale, dove il paziente inserisce i suoi dati e sintomi per ricevere una pronta diagnosi e relativa prescrizione, il tutto in pochi minuti. Sarebbe ancora necessario un medico del territorio? Stiamo andando in quella direzione che per le casse dello Stato conviene percorrere fino in fondo con l’informatizzazione globale del medico di base, oppure l’approccio umano servirà ancora?
Temo che quest’ultimo sarà riservato solo a pazienti paganti…
Enzo Bozza
Medico Mmg a Vodo e Borca di Cadore (BL)