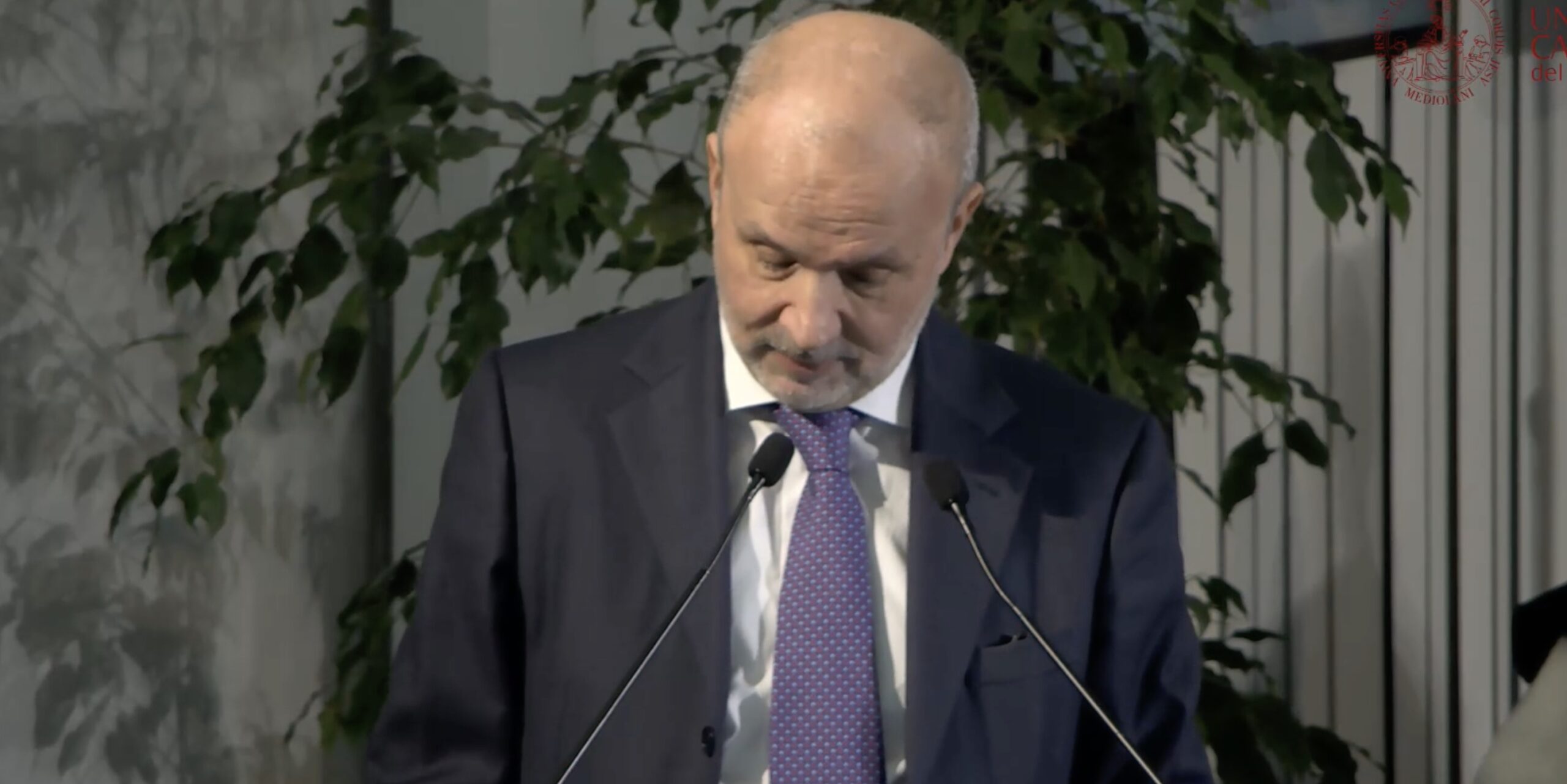Gentile Direttore,
quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale, l’interesse tutelato era chiarissimo: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.” (art. 1 Legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Nel tempo, questo interesse chiarissimo – la salute – si è progressivamente contaminato di interessi altri e impropri per un servizio sanitario, quali quelli giudiziari e di controllo sociale, per l’infiltrazione di richieste di valutazione sempre più frequenti da parte dei tribunali (e loro delegati), su cittadini e su pazienti.
Interessi legittimi per uno stato e necessari per la collettività, nessuno lo nega. Ma che non dovrebbero interferire con le attività di cura, che perseguono un interesse diverso e altrettanto degno di tutela quale quello alla salute.
La tutela della salute non può fare a meno del segreto professionale. Il segreto è un principio che permea l’esercizio delle professioni sanitarie fin dal giuramento di Ippocrate, è un precetto penale ed insieme alla consensualità del contratto è un pilastro fondante delle deontologie di tutte le professioni.
Il segreto ha una precisa funzione nel perseguire il diritto alla salute: se i cittadini iniziassero ad immaginare che le loro patologie fisiche o mentali, le loro abitudini o i loro sintomi comportamentali, tossicologici, sessuali, le loro attitudini problematiche, e tutto ciò per cui chiedono ai professionisti sanitari una cura, potrebbero un giorno essere da questi comunicate ad un giudice e produrre per loro effetti negativi (carcerazioni, allontanamento di figli, etc), quale fiducia potrebbero nutrire nei curanti?
Eppure, attraverso una serie di passaggi, i servizi sanitari sono stati progressivamente caricati di incombenze valutative, sdoganando e normalizzando una violazione sistematica del segreto professionale per fini giudiziari e di controllo sociale.
Ecco alcuni di questi passaggi:
– Il DPCM 23 aprile 2008 introduce fra i LEA per i servizi di socio-sanitari i ‘rapporti con il Tribunale’;
– Il DPR 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico sulle droghe, attribuisce ai SerD funzioni che impattano direttamente sulla condizione giudiziaria e detentiva dei pazienti, in senso anche svantaggioso;
– L’articolo 473 bis 27 c.p.c. introdotto con la riforma Cartabia, attribuisce al giudice il potere di disporre “l’intervento dei servizi sociali o sanitari”, come fossero una sorta di polizia sanitaria;
– Il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale attualmente in discussione prevede in diversi passaggi una funzione forense strutturalmente incastonata nei servizi cura.
Tutto questo va ben oltre i classici istituti che costituiscono giusta causa di violazione del segreto professionale, quali lo stato di necessità, la testimonianza o il discusso obbligo di referto, per i quali vi sono comunque limiti e garanzie a tutela della riservatezza dei pazienti e del dovere al segreto del sanitario.
Siamo entrati in un campo in cui non si riflette più sul bilanciamento fra interessi di salute e interessi di giustizia, e spesso si agisce senza discernimento, come se rivelare notizie cliniche di un paziente su indicazione dell’autorità giudiziaria sia scontato e dovuto.
Tutto questo rischia di trasformare i sanitari in delatori. Ad essere più esposti sono i consultori familiari, i servizi per le dipendenze e per la salute mentale, in cui si seguono situazioni molto fragili e delicate, dove il rapporto fiduciario è il primo motore della cura e la riservatezza è un patto necessario affinché la persona possa affidarsi e confidarsi al curante, esponendogli tutto ciò che vive, anche quando si tratta di fatti drammatici, incresciosi, illeciti, violenti, senza il timore di averne conseguenze.
La permeabilità con cui certe informazioni si diffondono dal luogo della cura ai luoghi della giustizia nuoce gravemente alla salute.
Pochi giorni fa, una mia paziente ha lucidamente riassunto il problema in questa frase: “Non posso più dirle tutto, perché temo le conseguenze”.
A questo abbiamo ridotto i nostri pazienti? A malati che non si possono fidare di chi li cura, che omettono sintomi perché temono conseguenze giudiziarie dalla propria patologia?
Vi è poi un ulteriore problema: la compressione del diritto di difesa. Perché quando a svolgere una valutazione a scopo forense è un servizio sanitario pubblico, non vi sono consulenti di parte e di controparte a garanzia della correttezza del processo, come avviene nelle CTU.
Se poi il professionista che cura è costretto anche ad assumere un ruolo di valutazione, la situazione diviene un nodo gordiano impossibile da districare. Da questi dispositivi pasticciati nasceranno inevitabilmente valutazioni viziate nel metodo e nel fine, compromettendo al tempo stesso la possibilità della cura.
Di fronte a tutto questo, i sanitari oscillano tra inconsapevolezza, eccessi di cautela autodifensiva, obbedienza acritica (“Se ce lo chiede il giudice, dobbiamo…”), resistenza critica, burn out, tentativi di informarsi, resa di fronte alla complessità etica, deontologica e giuridica della questione.
Verrebbe la tentazione di dare la colpa di tutto questo intrico al legislatore, ai servizi, ai giudici, all’accademia, alle aziende sanitarie ed a chissà quale altro nuovo santo. E di certo agli ordini professionali territoriali e nazionali, ricchi di post sui social, commissioni varie e convegnistica raffinata, ma bellamente addormentati di fronte ai problemi etici e di ruolo della realtà professionale.
Per gli psicologi, hanno finora preso posizione solo il sindacato AUPI e l’associazione di categoria Altrapsicologia. Per il resto tutto tace.
Ma la responsabilità qui è di tutti: tutti abbiamo accettato questo lento incedere verso la normalizzazione dell’anomalo, come tante rane bollite.
Quali le soluzioni possibili? Sicuramente, intanto quelle che sono già a portata di mano, che sono già previste dall’ordinamento e dalle deontologie professionali: lo scorporo delle esigenze di giustizia dai dispositivi di cura; la dispensa dei curanti dal riferire in merito alle condizioni di salute dei propri pazienti, se non in particolari circostanze e comunque sempre a loro tutela, mai contro i loro interessi, sempre con il loro consenso; l’esercizio delle funzioni valutative affidato a valutatori terzi che non abbiano compiti di cura e siano incaricati dal giudice; la garanzia del contraddittorio in ogni fase.
Si otterrebbe una migliore tutela dei minori, dei soggetti fragili, dei pazienti. Si libererebbe il sanitario che ha in carico la cura da oneri che la ostacolano. E probabilmente, in uno spazio sicuro e riservato, anche i pazienti la cui condizione rapppresenta un rischio per gli altri avrebbero qualche chanche in più per curarsi efficacemente.
Ma io credo, egregio Direttore, che a prescindere dai rimedi di sistema, ciascun sanitario debba assumersi anche in prima persona la responsabilità del proprio agire, ponendosi in modo critico e deontologicamente consapevole di fronte ad ogni richiesta che possa danneggiare, in concreto o anche solo potenzialmente, l’interesse alla salute dei propri assistiti, unico fine non negoziabile.
Federico Zanon
Psicologo
Socio fondatore di Altrapsicologia
Coordinatore Ufficio Deontologico Ordine Psicologi Veneto
Consigliere ENPAP
Dirigente psicologo ASL
già vicepresidente e consigliere di amministrazione ENPAP
già presidente di Altrapsicologia
già consigliere Ordine Psicologi Veneto