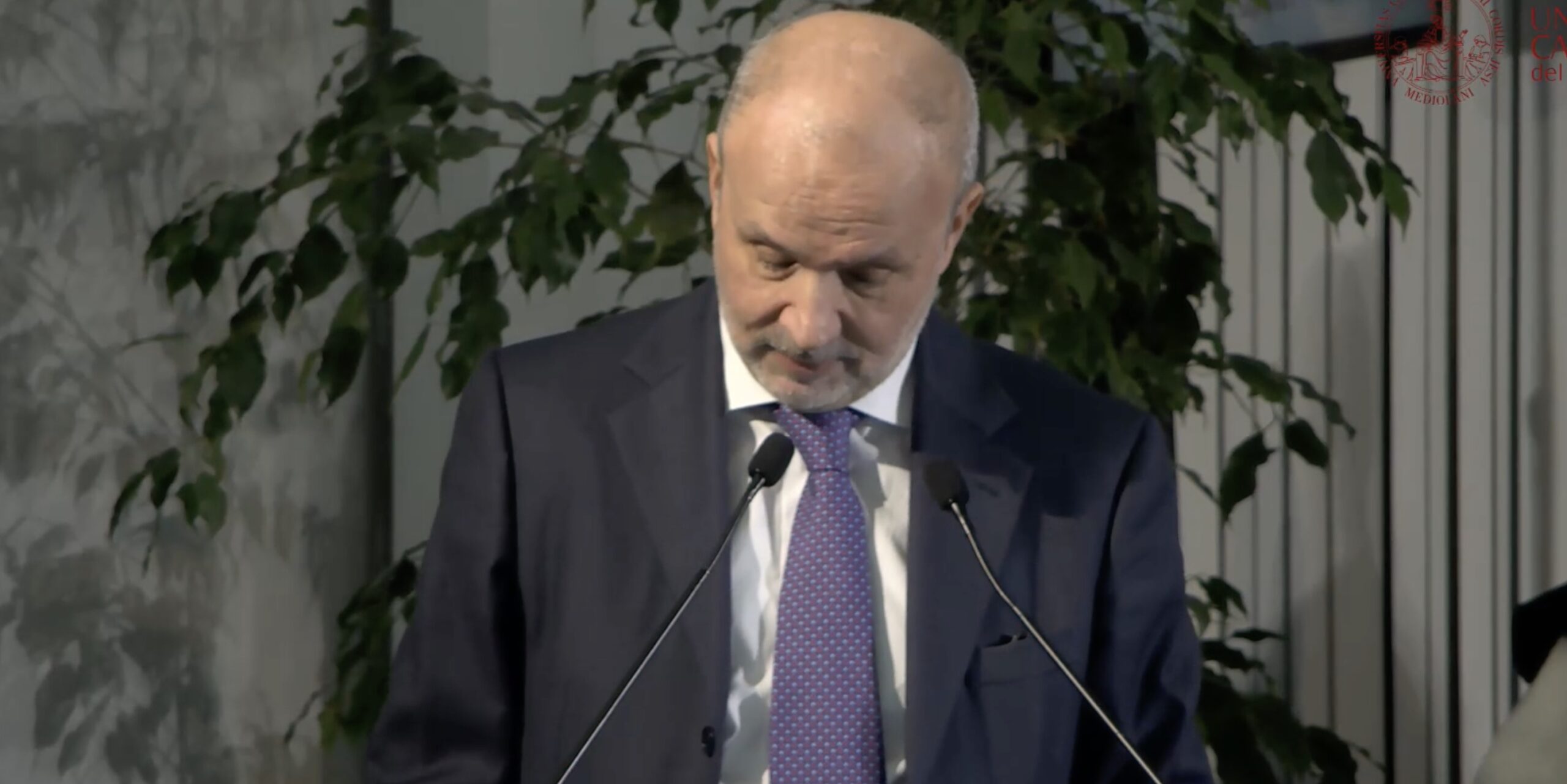Gentile Direttore,
sono passati oltre venticinque anni dalla pubblicazione della Legge 251 del 2000, che avrebbe dovuto accompagnare le professioni sanitarie verso una piena autonomia e la costruzione di una propria dirigenza. L’obiettivo era chiaro: superare il modello dell’operatore sanitario ausiliario e subordinato, creando una figura dirigenziale responsabile dell’organizzazione dell’assistenza, garante della qualità professionale e interlocutore della direzione strategica.<
Quel disegno, però, è rimasto in larga parte incompiuto. Come spesso accade nella legislazione sanitaria italiana, il principio è stato affermato, ma l’architettura organizzativa necessaria a renderlo operativo è rimasta vaga e soprattutto disomogenea nell’attuazione regionale. Ruoli, poteri, responsabilità e collocazione gerarchica del dirigente delle professioni sanitarie non sono mai stati definiti in modo chiaro e uniforme.
Il risultato è una figura formalmente dirigenziale ma sostanzialmente ibrida: spesso collocata a valle delle decisioni strategiche, più esecutore che decisore. A questa posizione si accompagna una evidente asimmetria: al dirigente vengono attribuite responsabilità elevate sulla qualità dell’assistenza e sull’organizzazione del lavoro, senza un reale controllo sulle risorse né una piena partecipazione ai processi decisionali. Una responsabilità senza leve, che espone la figura a fragilità giuridiche e organizzative.
L’attuazione della Legge 251/2000 si è sviluppata in modo frammentato, con interpretazioni diverse da regione a regione e da azienda ad azienda. In alcuni contesti la dirigenza delle professioni sanitarie è stabilmente inserita nella governance; in altri resta marginale o puramente formale. Questa disomogeneità, favorita dall’autonomia regionale e dall’assenza di standard nazionali vincolanti, ha prodotto un quadro nazionale disarticolato, con effetti evidenti sull’efficacia dei modelli assistenziali e sulla chiarezza dei ruoli.
Le organizzazioni sanitarie non sono macchine lineari. Sono sistemi complessi, attraversati da confini, interdipendenze, micro-poteri, culture professionali e “rumore organizzativo”. In questo scenario la leadership non coincide con la posizione, ma con la capacità di leggere e governare ciò che accade nelle interfacce operative: consegne, accessi, agende, turni, urgenze, priorità. È lì che la teoria diventa pratica e lì che si misura il valore reale di una dirigenza.
A ciò si aggiunge un altro nodo irrisolto: la debolezza identitaria della dirigenza delle professioni sanitarie. Spesso percepita come una semplice evoluzione del coordinatore o come un’interfaccia amministrativa, fatica a esprimere una leadership professionale pienamente riconosciuta, chiamata erroneamente i dirigenti del comparto (sic). Ne derivano scarso investimento in una formazione realmente dirigenziale, conflitti latenti con altre dirigenze e una limitata capacità di incidere sulle politiche sanitarie. Una figura che potremmo definire “dirigente per titolo, ibrida per collocazione”.
Il problema, oggi, non è più dimostrare la competenza gestionale delle professioni sanitarie, ma trasformarla in ruolo, responsabilità e potere decisionale. Ai livelli più alti della governance in molte realtà la rappresentanza resta concentrata in un’unica professione. Non per una questione di valore, ma per un’asimmetria strutturale che limita l’accesso alle altre professioni, anche a parità o superiorità di titoli e responsabilità.
Il paradosso è evidente: professionisti con alta formazione, competenze avanzate e forte esposizione tecnologica incidono poco sulle scelte organizzative. Il gap non è formativo, ma politico e organizzativo. La domanda è inevitabile: perché alcune professioni accedono naturalmente alla dirigenza e altre no, indipendentemente dal merito?
La domanda è lecita e la risposta è sempre stata taciuta, ma nella quasi totalità del territorio nazionale, la funzione dirigenziale di vertice è ricoperta in modo pressoché esclusivo da un unico profilo professionale. Non si tratta di un fatto episodico o locale, ma di una configurazione sistemica che attraversa regioni e aziende sanitarie, rendendo in molti casi l’accesso delle altre professioni ai livelli apicali un’eccezione più che una possibilità ordinaria. Sebbene il sistema si fondi su una pluralità di professionisti che operano in complementarietà lungo il processo assistenziale, questa esclusività finisce per produrre disparità anziché ridurle.
La presenza di singole figure provenienti da professioni diverse in ruoli apicali non modifica, tuttavia, il quadro generale. Le eccezioni in alcune Regioni, per quanto significative, non costituiscono un modello strutturale: dimostrano che l’accesso è possibile, ma non che sia equo, prevedibile o sistemico. Nella pratica quotidiana del Servizio sanitario nazionale, i principali snodi decisionali restano infatti fortemente concentrati, secondo assetti di potere consolidati che prescindono spesso dal merito, dai titoli o dalla complessità delle competenze esercitate.
Il nodo, infatti, non riguarda il valore di una professione rispetto alle altre, ma la persistenza di una governance di fatto monocentrica. Professioni ad alta specializzazione tecnica e gestionale, come quelle dell’area tecnico-sanitaria, come quelle della riabilitazione o della prevenzione continuano a incidere solo marginalmente sulle scelte organizzative strategiche, non per deficit formativi, ma per una distribuzione del potere che risponde più a inerzia storica e convenienza organizzativa che a criteri di efficacia complessiva del sistema.
Se questo nodo non verrà affrontato apertamente, anche innovazione, autonomia territoriale e nuovi modelli organizzativi resteranno dichiarazioni di principio.
Comunque, le altre professioni devono continuare a formarsi, da un lato, e a cercare strategie risolutive dall’altro. Servono a questi scopi, scelte intenzionali, come ad esempio:
– un rafforzamento della formazione manageriale specifica per il ruolo dirigenziale, fino a ipotizzare percorsi formativi dedicati e uniformi a livello nazionale, come un Master specifico con un adeguato numero di CFU o una laurea specialistica biennale autonoma;
– un’azione di lobbying finalizzata all’emanazione di linee guida attuative della Legge 251/2000, capace di ridurre le disomogeneità regionali e rendere comparabili ruoli e strutture nel SSN.
Infine, una riflessione per chi governa la politica professionale: oggi la questione non è più quella di dimostrare la maturità delle altre professioni sanitarie, ma di riconoscere l’esistenza di una scelta politica e organizzativa che continua ad attribuire in molte realtà quasi esclusivamente a una sola professione il ruolo gestionale del sistema. Una scelta sostenuta più da inerzia e comodità istituzionale che da evidenze di efficacia. Se la centralità di un’unica professione fosse davvero risolutiva, non assisteremmo alle criticità diffuse che oggi caratterizzano il sistema.
Non si tratta di contrapporre le professioni, ma di garantire pari accesso ai livelli decisionali, valorizzando l’insieme delle competenze e dei risultati, si tratta di valorizzare l’unità nella diversità che non è uno slogan ma un valore aggiunto realmente strategico. La domanda, oggi, non è se serva una dirigenza delle professioni sanitarie, ma che tipo di dirigenza vogliamo: una figura ornamentale, utile al decoro dell’organigramma, o un ruolo capace di abitare le interfacce, ridurre entropia e trasformare competenze distribuite in scelte organizzative e risultati misurabili.
Perché in sanità, quando la governance resta monocorde, il sistema non diventa più ordinato: diventa solo più rumoroso.
Queste riflessioni sono rivolte a chi, nei ruoli politici, ordinistici e sindacali, è chiamato a governare il futuro delle professioni sanitarie. Perché una dirigenza formalmente riconosciuta, ma priva di reale potere decisionale, non rafforza né le professioni né il Servizio sanitario nazionale.
Roberto Di Bella
Danilo Pasini
Barbara Pelos
Saverio Proia
Renzo Ricci
Floriana Simeone
Liberi pensatori