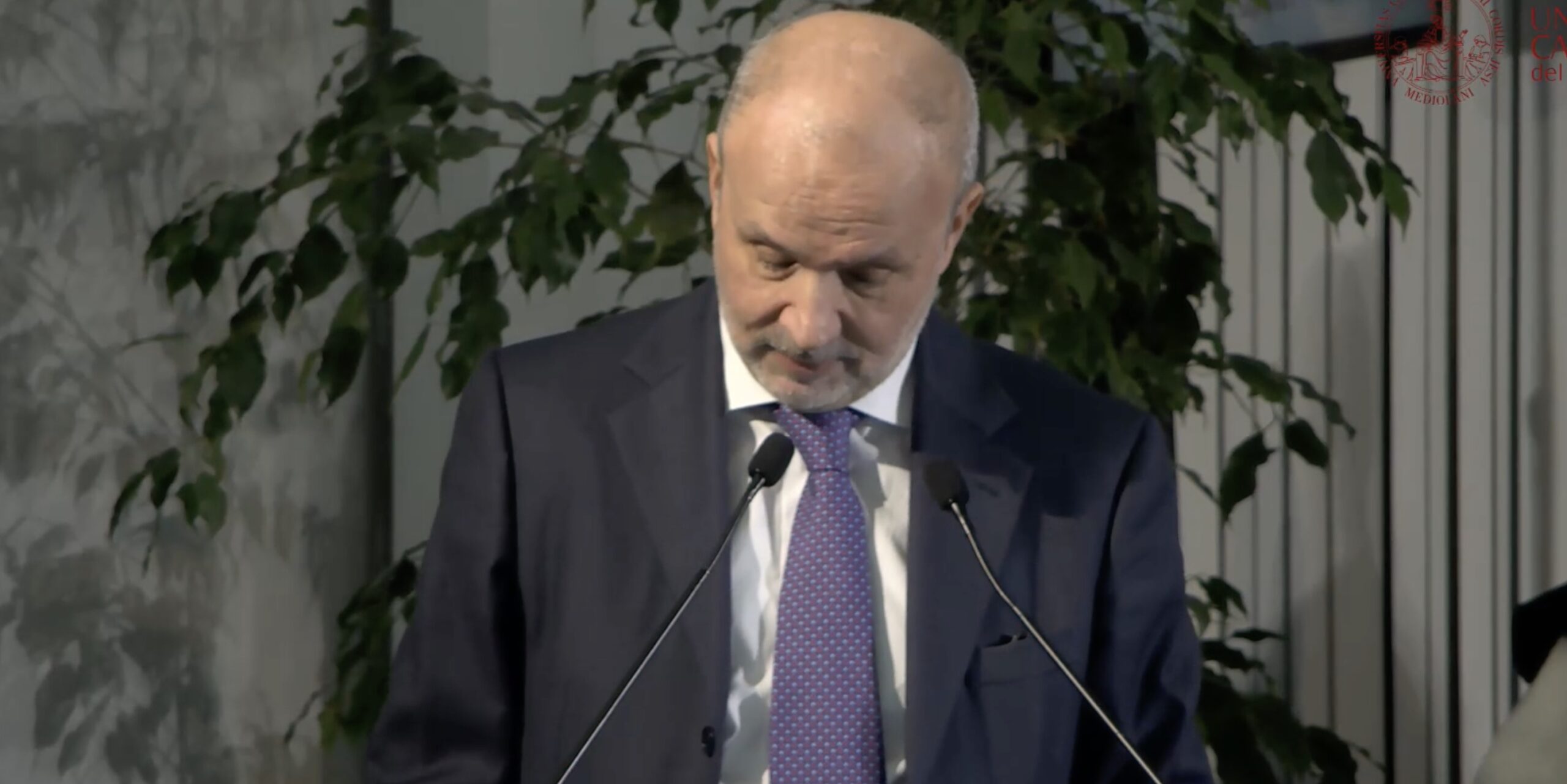Gentile Direttore,
la giurisprudenza e la legislazione italiana degli ultimi quindici anni hanno tracciato un percorso coerente e progressivo nel riconoscimento del diritto delle persone all’autodeterminazione, anche nelle fasi più complesse e drammatiche dell’esistenza.
La legge n. 38 del 2010 ha garantito l’accesso universale alle cure palliative e alla terapia del dolore; la legge n. 219 del 2017 ha codificato il principio del consenso informato e il diritto di ogni individuo a rifiutare trattamenti sanitari; infine, la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale ha sancito la non punibilità dell’aiuto al suicidio in casi circoscritti, ma emblematici, affermando che, in presenza di gravi condizioni mediche e di una volontà libera, consapevole e attuale, lo Stato non può imporre, mediante il diritto penale, un vincolo assoluto alla scelta individuale sul proprio fine vita.
Tale impianto normativo si fonda sul riconoscimento dei diritti umani universali e inalienabili – in particolare il diritto alla dignità, all’autodeterminazione e alla libertà personale – come sanciti dalla Costituzione italiana, dalle principali Carte internazionali sui diritti fondamentali della persona e in coerenza con i principi affermati dalla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano rispetto alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo, 1997), che tutela l’autonomia della persona nelle decisioni in ambito sanitario e ne riconosce la dignità anche nella fase ultima della vita.
Il disegno di legge intitolato Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242 si presenta formalmente come attuativo della pronuncia in questione, ma sembra alterarne profondamente lo spirito e rischia di sottrarre alla persona sofferente ciò che le spetta per diritto: ascolto, vicinanza, cura e tempo empatico.
Già all’articolo 1, il disegno di legge afferma il principio di “indisponibilità assoluta della vita”, prescindendo dalla realtà concreta della pratica medica, che interviene quotidianamente su ogni fase dell’esistenza, dalla nascita fino alla morte. Tale impostazione sembrerebbe in antitesi rispetto all’intreccio costituzionale tra il diritto alla vita, il diritto alla salute, la libertà personale e la dignità umana, i quali non possono essere considerati separatamente, né subordinati a un principio astratto e unilaterale di tutela della vita biologica.
Inoltre, la scelta di accorpare le valutazioni presso un unico Comitato nazionale, anziché istituire commissioni multidisciplinari territoriali, potrebbe compromettere la sostenibilità dell’intero sistema, nonché la prossimità e la possibilità di incontro diretto, eludendo che solo all’interno di una relazione significativa è possibile cogliere pienamente la profondità della sofferenza.
Per queste ragioni, il Gruppo di Lavoro Fine vita ed Etica del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha condiviso alcune riflessioni e proposto emendamenti volti a ristabilire coerenza e chiarezza normativa, riaffermando principi essenziali per una disciplina giuridica rispettosa della persona: la centralità della relazione terapeutica, il riconoscimento della soggettività della sofferenza, la necessità di commissioni territoriali multidisciplinari e la garanzia di un supporto psicologico e sanitario continuativo, dignitoso e integrato in tutte le fasi dell’iter fino alla fine del percorso. Solo attraverso una legge unitaria, comprensibile e fondata sull’ascolto, sull’autonomia e sull’autodeterminazione, sarà possibile dare piena attuazione al mandato costituzionale espresso dalla sentenza n. 242/2019, costruendo una disciplina autenticamente democratica e umana del fine vita.
Laura Berretta
Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria