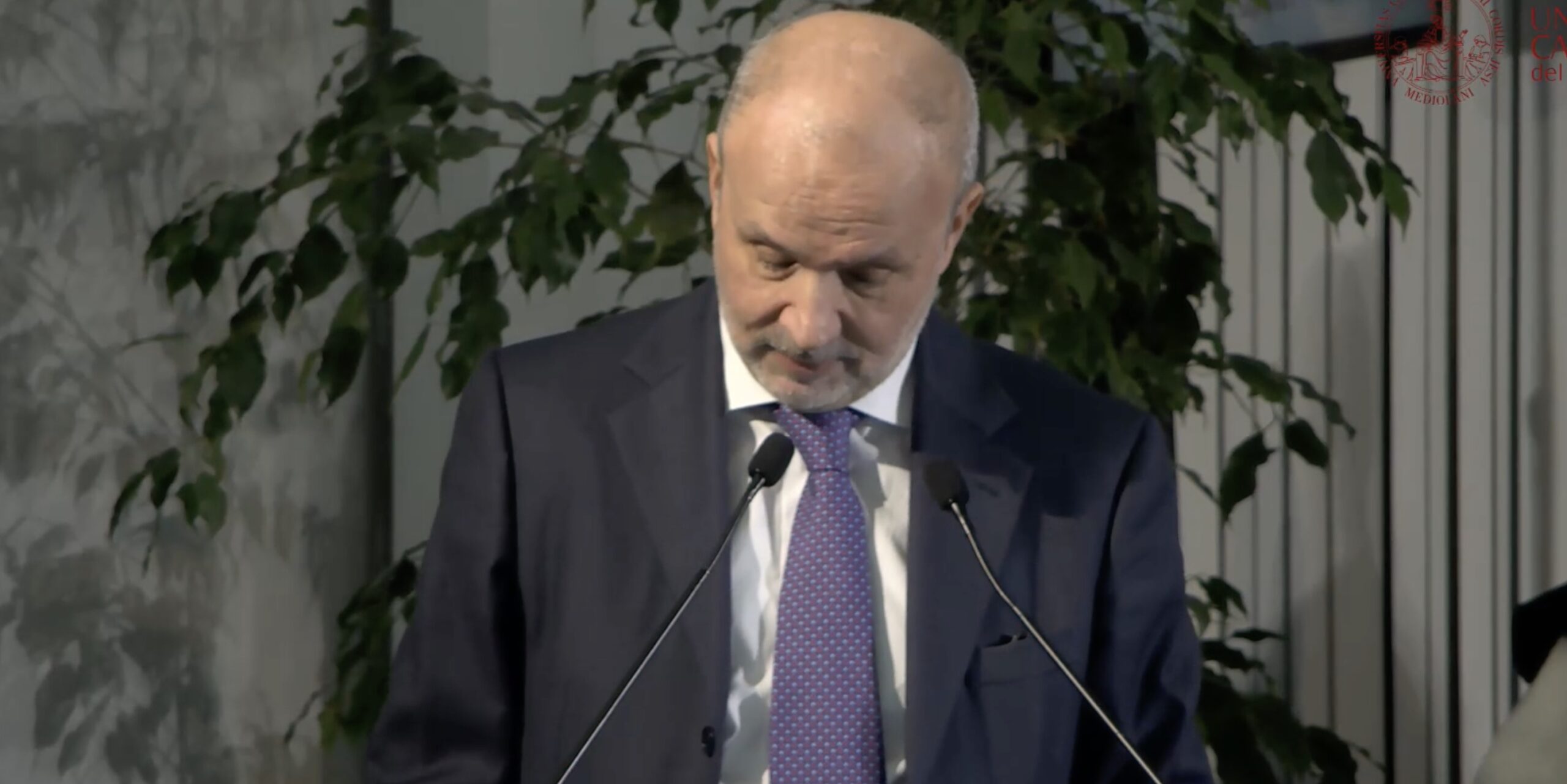Gentile Direttore,
la recente Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 624 del 17 luglio 2025 – Aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni rivolte alle persone affette da disturbo della salute mentale – è un caso emblematico che va ben oltre il contesto locale e il tema specifico delle comunità terapeutiche.
Le sue implicazioni toccano un nodo cruciale: il modo stesso di intendere la salute mentale e la riabilitazione. Non è solo una questione tecnica o economica: il rischio è piegare la cura a una logica di gestione contabile, svuotandola del suo senso terapeutico e umano. È un tema che interroga direttamente la capacità del sistema di mantenere vivo il cuore del nostro lavoro: il progetto terapeutico, la continuità della cura e il valore trasformativo della riabilitazione.
1. Niente retta dall’undicesimo giorno: il rischio della dimissione forzata
La delibera stabilisce che, in caso di assenza del paziente per ricovero ospedaliero non programmato o accesso urgente in pronto soccorso, venga riconosciuto l’80% della retta solo per i primi dieci giorni consecutivi; dall’undicesimo in poi, nessun riconoscimento economico. Per le assenze programmate, l’80% è riconosciuto senza limite di giorni, ma comunque in misura ridotta. In pratica, per evitare di perdere la retta, si può essere indotti a dimettere il paziente al 10° giorno, con il rischio che al rientro – in un contesto , come noto , di posti scarsi – non trovi più accoglienza. Ciò compromette tanto la continuità terapeutica quanto la sostenibilità della struttura.
2. Rientri in famiglia: penalizzazione delle tappe terapeutiche
Persino i rientri brevi in famiglia, previsti nei progetti individuali, subiscono la riduzione della retta. Weekend a casa per testare l’autonomia, rafforzare i legami familiari o verificare la tenuta in contesti protetti vengono trattati come semplici assenze. Il segnale implicito è controproducente: invece di incoraggiare passaggi chiave della riabilitazione – prove relazionali, esperienze di responsabilizzazione – li si penalizza economicamente, scoraggiandone l’attuazione.
3. La natura delle comunità estensive: movimento, non stasi
Le comunità terapeutiche estensive hanno per mission la riabilitazione psicosociale e il reinserimento nel territorio. Il loro modello prevede, per natura, uscite, rientri, interruzioni temporanee e flessibilità. Non è un’anomalia, ma parte integrante del percorso. Valutare la qualità di un intervento unicamente in base alle giornate di presenza significa ignorare la specificità clinica e riabilitativa di queste strutture.
4. Conta la presenza o il progetto?
La retta dovrebbe seguire il progetto terapeutico, non la sola presenza fisica. È comprensibile che l’amministrazione pubblica utilizzi una tariffa giornaliera per ragioni contabili, ma occorre che questa rifletta il valore complessivo del percorso, comprendendo anche le tappe fuori sede. Non accompagniamo occupanti di letti, ma persone in evoluzione: ogni uscita è un segmento di cura, non un’assenza. Non riconoscerlo significa ridurre il progetto terapeutico a un contratto alberghiero.
5. Il rischio culturale: verso una neo-istituzionalizzazione silenziosa
Se “più il paziente resta, più la struttura guadagna”, il sistema incentiva la staticità e scoraggia il movimento. Così si rischia di produrre una neo-istituzionalizzazione silenziosa, che non si dichiara ma si realizza: il paziente passivo, poco coinvolto diventa più “conveniente” di quello attivo e in cambiamento. Questo altera in profondità la mission delle strutture, compromettendo il senso trasformativo della terapeuticità.
6. Il paradosso: se pensi, ci perdi. Se non pensi ci guadagni
Qui sta il punto più inquietante: chi prova a fare le cose per bene ci rimette. Chi riflette sulle ricadute cliniche, chi mantiene aperto un progetto nei momenti critici, chi sceglie di non dimettere un paziente fragile pur sapendo di rinunciare alla retta, subisce una perdita economica certa. Al contrario, chi applica la norma meccanicamente – dimettendo al 10° giorno, evitando rientri, scoraggiando uscite – viene premiato. Non perché lavori meglio, ma perché si muove dentro la logica economico-contabile del sistema.
Una delibera così, in mano a imprenditori o gestori privi di reale sguardo clinico, è “egosintonica”: non crea conflitto, anzi si armonizza con una visione puramente gestionale, dove il bilancio pesa più del percorso di cura. Si ribaltano i valori:
• la coerenza terapeutica diventa penalizzante
• la rigidità amministrativa diventa remunerativa
• la riflessione clinica viene sanzionata
• l’adesione cieca viene incentivata
confondendole con modelli residenziali intensivi o custodiali.
Pensare diventa un lusso, interrogarsi fa male al bilancio, non interrogarsi lo salva. In un mondo così, la qualità del lavoro diventa un rischio, non un valore.
Conclusione
Non è mio compito proporre soluzioni tecniche: parlo da clinico, con il bisogno di tenere insieme la cura delle persone e la tenuta delle istituzioni che le accolgono. Queste riflessioni non vogliono essere una denuncia, ma un invito al confronto. Se smettiamo di interrogarci sul senso delle scelte, rischiamo di smarrire il cuore del nostro lavoro. E quando la ragione si addormenta, il rischio di generare mostri diventa reale. Sta a noi mantenere viva la riflessione e il senso critico, per non perdere di vista ciò che conta davvero: la cura, la dignità e il valore umano del nostro operato.
Prof Claudio Bencivenga
Università degli Studi di Parma
Consiglio Direttivo dell’Assoc. nazionale Comunità Terapeutiche “Mito & Realtà”
Comitato Scientifico FENASCOP Federazione Nazionale Comunità Psicosocioterapeutiche
Consigliere Ordine degli Psicologi del Lazio
Consigliere onorario presso la Corte di Appello di Roma