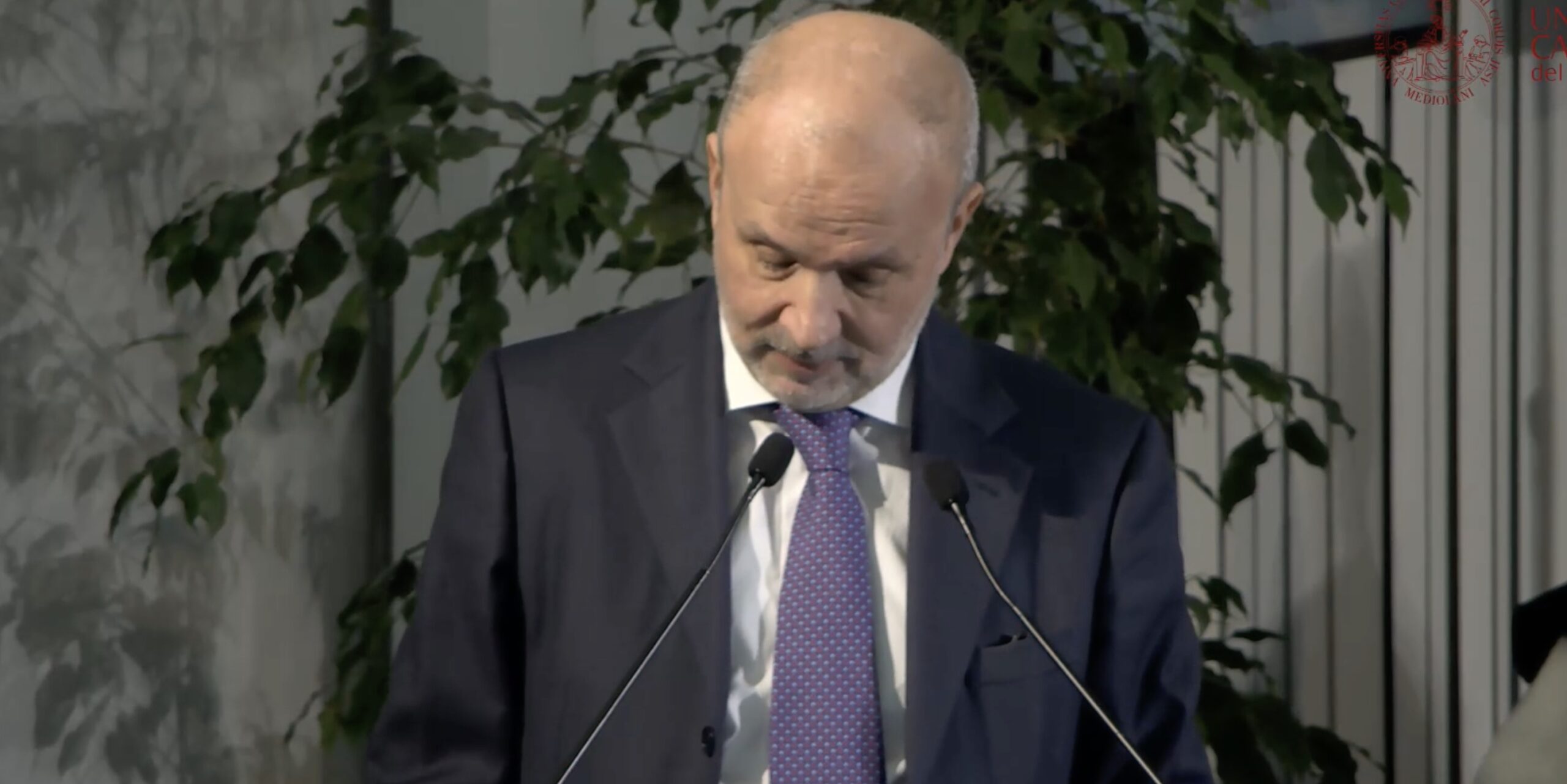Gentile Direttore,
la medicina è stata definita “La scienza dell’incertezza e l’arte della probabilità”. Anche la deontologia medica prevede che il medico debba decidere secondo “scienza e coscienza”. La legge prevede che il medico debba decidere secondo il diritto del malato e l’interesse della collettività dell’art.32 della Costituzione, i principi di universalità, uguaglianza, equità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della legge 833/78, secondo le linee guida e le buone pratiche assistenziali della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale, secondo la corretta informazione della legge 219/2017 sul consenso informato.
Per rendere sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale lo Stato suggerisce e in qualche modo esige percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali di appropriatezza prescrittiva e budget economici. Il medico viene penalizzato o premiato in base all’aderenza a queste disposizioni, dimenticando gli assiomi iniziali: l’incertezza e la probabilità insite nella definizione di medicina. Come si fa ad essere appropriati se operiamo in un contesto di incertezza e probabilità, dove ogni decisione è una scommessa?
La burocrazia per funzionare ha bisogno di certezze che né la scienza né la coscienza può dare. L’appropriatezza è un tentativo ideologico della medicina amministrata, inesistente nella realtà, necessaria per rendere sostenibile il sistema. Lascia però il cerino acceso nelle mani del medico che accetta o fa finta di accettare perché, se è un buon medico, sa che l’appropriatezza vale per il paziente “teorico” non per quello “reale”. Nessun paziente accetterebbe volentieri l’appropriatezza nel suo caso personale. Diceva un anziano economista: “il ricco fa gli esami che vuole, il povero quelli che può”.
La probabilità è misurabile in un insieme di pazienti, non nel singolo individuo dove prevale il caso e quindi la necessita della condivisione. Il medico, sia se accetta per convinzione o per finta non fa comunque una bella figura sia nei confronti del paziente sia riguardo la sua autostima. Lega l’appropriatezza ad un piatto di lenticchie ma la sua autorevolezza personale precipita.
L’appropriatezza intesa come probabilità, insieme alla evidenza e prove di efficacia, alla esperienza ed intuizione personale del medico e alle preferenze del paziente sono strumenti utili se lasciati alla discrezionalità del medico imprenditore per la salute e non alla obbedienza del medico burocrate.
L’appropriatezza in un sistema regolato è l’equivalente del prezzo nel mercato. Dipende dall’equilibrio tra domanda ed offerta. Se la domanda sale e l’offerta è inadeguata, nel mercato sale il prezzo, in un Servizio Sanitario Nazionale si allungano le liste di attesa, che la burocrazia cerca di contenere in un’orgia di prestazioni senza fine. Ma il vero problema non è quello. Il medico ha bisogno di curare e governare non solo la mente e il corpo ma soprattutto l’anima del paziente intesa in senso laico.
“Che ne sanno i dottori dei bisogni dell’anima di una persona?” dice Don Pedro Aragon nel film “Il profumo del mosto selvatico”. Spesso non lo sa nemmeno il paziente stesso. La cura dell’anima bisogna chiederla alla filosofia per chi non crede e alla religione per chi crede, in un groviglio inestricabile di impulsi diversi che ognuno razionalizza a modo suo nella direzione che gli pare più giusta o più conveniente. Alla fine, la buona cura diventa una scommessa che il paziente fa con sé stesso con il tentativo di governo da parte del sistema che ricorre anche alla più odiosa burocrazia pur di assoggettare la scienza e la coscienza del medico, addirittura pagandolo per essere appropriato.
Emma Bonino, già da nove anni affetta da tumore polmonare, dopo dieci giorni di ricovero in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria, viene intervistata mentre fuma una sigaretta. Dice subito “Niente prediche”. Le prediche per la salute si possono fare alla mente, non all’anima. È difficile darne una definizione in un senso che non sia religioso ma laico. Nella cultura greca poteva identificarsi con il “daimon”, una voce segreta, un richiamo che ci invia messaggi, ci induce a realizzare il nostro destino e diventare ciò che autenticamente siamo.
L’anima non può essere sottoposta alla dimostrazione sperimentale secondo i canoni scientifici. Non si può definire ciò che è appropriato e ciò che non è appropriato. È il campo dello squisitamente soggettivo, irrazionale, metafisico. Il benessere dell’anima si intreccia con quella della mente e del corpo ma il suo benessere è diverso, così che i vizi possono migliorare il benessere meglio delle virtù e la ragione potrebbe avere torto. Hanno provato a capirla filosofi, religiosi, scienziati ed artisti ma con interpretazioni di parte, il più delle volte ideologiche. Affidarsi al metodo scientifico in una materia che non è scientifica è fuorviante.
Per tentare di governare l’anima intesa in senso laico, oltre che il corpo e la mente, niente è più sbagliato del medico sottomesso alla burocrazia, alla medicina amministrata o alla “triadic care” della intelligenza artificiale. È un fallimento sicuro, per la confusione che si fa tra prestazione e cura.
Il medico se necessario deve ridurre le prestazioni ed il fatturato se agisce nell’ambito di un Servizio pubblico. Il suo compito è quello di produrre salute, non prestazioni. Deve insegnare e condividere con il paziente l’accettazione del rischio, la probabilità del risultato e la casualità dell’evento in un contesto di certezza dei mezzi messi a disposizione dall’organizzazione. Per fare questo deve essere un imprenditore di salute che agisce su corpo, mente ed anima, secondo scienza, evidenza, coscienza, incertezza, probabilità ed empatia. Se accetta o è costretto al ruolo di burocrate, il paziente “reale”, per essere curato bene, deve sperare di assomigliare il più possibile a quello “teorico”. Una persona senza anima.
Franco Cosmi
Medico cardiologo, Perugia