
Fanos (SIN): “Attenzione, non tutti gli eventi avversi in sanità sono conseguenza di errori”

Quotidiano Sanità ha rigirato alcune di queste domande a Vassilios Fanos, neonatologo dell'Università di Cagliari, tesoriere della Società italiana di neonatologia e membro della Commissione Nazionale Risk Management che ha condotto la ricerca.
Uno studio simile a quello pubblicato, ma riguardante l’ambito pediatrico e non quello strettamente neonatale è stato pubblicato quest’anno in Francia. È possibile fare un confronto dei dati?
Lo studio francese è leggermente diverso da quello italiano: nella casistica francese pubblicata quest’anno, la prima disponibile in Europa, le denunce riguardanti i casi neonatali sono state escluse ed è noto che esse rappresentano, nella stessa Francia, più della metà dei casi di denunce relative a tutte le età pediatriche. È quindi molto difficile paragonare i dati; i nostri paesi hanno sistemi sanitari diversissimi, diverso il periodo considerato con conseguenti differenti percentuali di denunce (che aumentano in tutti i casi nel corso degli anni). I dati da noi già pubblicati riguardano proprio l’area neonatale; i dati pediatrici saranno oggetto di una nostra seconda pubblicazione.
Dunque una differenza importante nello stesso impianto degli studi. L’unica ricerca simile a questa è quella giapponese, che ha dati più bassi. Ma esistono altre analisi a livello mondiale i cui risultati possono essere messi in relazione a questi?
I dati disponibili sono pochi, ma un confronto globale di tutte le età pediatriche ci porterebbe verosimilmente a valori simili a quelli degli Stati Uniti. Lì quasi 8 denunce su 10 riguardano i bambini al di sotto di 1 anno di età. Mi pare che un commento diverso da questo sia inappropriato, anche tenuto conto della limitatezza dei dati in termini assoluti. Il dato certo è l’incremento di citazioni per veri o presunti danni neonatali in Italia nel corso degli ultimi anni.
Spesso viene chiamata “malasanità”, ma in realtà noi non conosciamo ancora l’esito di molti dei processi considerati nello studio.
Parlare di malasanità sembra improprio, almeno parzialmente, anche se questo termine è entrato nel linguaggio dei giornali e dei media. Una denuncia non corrisponde necessariamente a un caso di malasanità e/o di condanna da parte della magistratura: non tutti gli eventi avversi in sanità sono conseguenza di errori ma, sempre più spesso, divengono oggetto di denuncia nei confronti delle strutture e dei medici. Per questa ragione, alla fine dei processi (soprattutto in sede penale) i dati di “presunta malasanità” sono sicuramente molto ridimensionati.
La notevole complessità dell’intervento medico è spesso trascurata nella comunicazione dei mass media. Le parole pesano e, per gli operatori sanitari da un lato e per l’opinione pubblica dall’altro, sentire costantemente parlare di malasanità, di omicidio colposo e assistere a sommari processi mediatici non giova alla comprensione del fenomeno. La medicina difensiva, anche se non condivisibile, finisce per essere un tentativo di risposta, in assenza di una seria presa in carico del problema da parte delle istituzioni.
Secondo lei dove bisogna indagare e cosa bisogna migliorare in Italia in questo campo?
Credo che da un lato occorra implementare studi seri oggettivi e di respiro nazionale sulla rilevazione degli errori e sulle modalità di prevenirli (su questo si sta lavorando molto) condividendo con le società scientifiche contenuti e modalità operative, ma anche far emergere con chiarezza le responsabilità organizzative delle amministrazioni. Su questo punto, occorre rilevare che la maggior parte degli eventi avversi non sono frutto di un errore commesso dal singolo medico, ma dipendono da un complesso processo organizzativo inadeguato (per modalità, carenza di personale o inefficienze tecniche) di cui il medico è solo l’ultimo anello terminale su cui si concentra tutta una serie di errori.
Dunque il problema andrebbe affrontato in termini complessivi.
È opportuno valutare chi ha fatto che cosa in quali condizioni organizzative e non limitare le riflessioni e l’analisi all’ultimo anello della catena. Adeguatezza delle strutture, adeguatezza della strumentazione (ad esempio non può essere posto sullo stesso piano un errore diagnostico compiuto utilizzando un ecografo top di gamma di ultima generazione oppure impiegando un ecografo vecchio di 15 anni o “low cost”), adeguatezza del numero del personale, ecc.
Il dato alla fine dei processi potrebbe venire ridimensionato. È stato pianificato di seguire gli esiti dei processi per denuncia, oppure ci sarà prima o poi modo di capire se effettivamente questo dato si traduca in una percentuale più alta di condanne per malasanità?
Certamente. Come Commissione Nazionale di Risk Management in Pediatria della Società Italiana di Pediatria (di cui fanno parte 2 pediatri ospedalieri, 2 neonatologi, un pediatra di famiglia, un giurista e un medico legale) abbiamo pianificato quello che lei chiede, anche se si tratta di dati non semplici da ottenere, perché mediamente occorrono moltissimi anni per concludere l’iter processuale (sia civile che penale) che fa seguito a una denuncia. Inoltre, a questi tempi lunghissimi, per i dipendenti pubblici si aggiungono gli ulteriori giudizi di rivalsa da parte della Corte dei Conti, che spostano il momento conclusivo ancora più avanti.
Un ulteriore riflessione importante, come già ricordato, è quella relativa alla medicina difensiva, alla quale i medici ricorrono perché vengono denunciati sempre più spesso e che chiaramente pesa sui costi del sistema sanitario nazionale. Sarà possibile risolvere questo problema, anche alla luce di quanto emerge dallo studio?
Questa domanda merita una riflessione serena. Chi opera per la salute, in particolare in aree critiche, si confronta necessariamente con situazioni-limite molto difficili da affrontare e risolvere e deve fare scelte decisive spesso in poco tempo, ma questi aspetti vengono solitamente trascurati. Parimenti un altro aspetto, su cui si stanno concentrando molti degli studi scientifici, è la complessità dei sistemi biologici (systems biology, systems medicine) da cui emerge l’estrema variabilità della risposta individuale alle malattie, alle infezioni, alla somministrazione di farmaci e alla stessa nutrizione.
Oltre alla medicina difensiva “attiva” (incremento degli accertamenti diagnostici solo a fini difensivi) e “passiva” (evitare di intervenire in situazioni complesse) se non si modifica lo stato delle cose il vero pericolo sarà che i giovani non si iscriveranno più alla Facoltà di Medicina (cosa già molto limitata dal numero chiuso oggi esistente) preferendo percorsi formativi meno “pericolosi” e, in ogni caso, quelli iscritti non sceglieranno le specialità più rischiose.
Secondo lei, quale può essere la soluzione?
Una possibile potrebbe essere la costituzione di una “cassa” per gli errori medici verificatisi nonostante la ricerca del best interest del paziente (così come esiste in Francia). Un esempio classico è il danno neurologico in grave prematuro. Spesso le famiglie denunciano il medico e la struttura solo per trovare un supporto economico necessario al trattamento di un bambino con handicap .
Peraltro non è pensabile che un singolo studio possa essere risolutivo, ma conoscere più da vicino un fenomeno aiuta ad affrontarlo. Le nostre società scientifiche stanno lavorando per migliorare la situazione e lo studio da noi pubblicato ne è una testimonianza. L’importanza che i neonatologi e i pediatri italiani attribuiscono alla tutela della salute dei piccoli pazienti li ha portati ad analizzare i dati del contenzioso per migliorare la qualità del servizio dato alla collettività. Collettività che spesso non recepisce questo sforzo “unilaterale” dei medici. Si potrebbe sottolineare la sensazione di solitudine “sociale” in cui il medico si trova oggi ad agire, medico che spesso ha la percezione di essere da solo ad interrogarsi seriamente sul problema della sicurezza e della salute del paziente.
L.B.
19 Dicembre 2011
© Riproduzione riservata

Gli speciali

Sanità digitale per garantire più salute e sostenibilità. Ma servono standard e condivisione
I più letti

Inibitori di Pompa Protonica. Aifa introduce una nota che ne regola la prescrivibilità
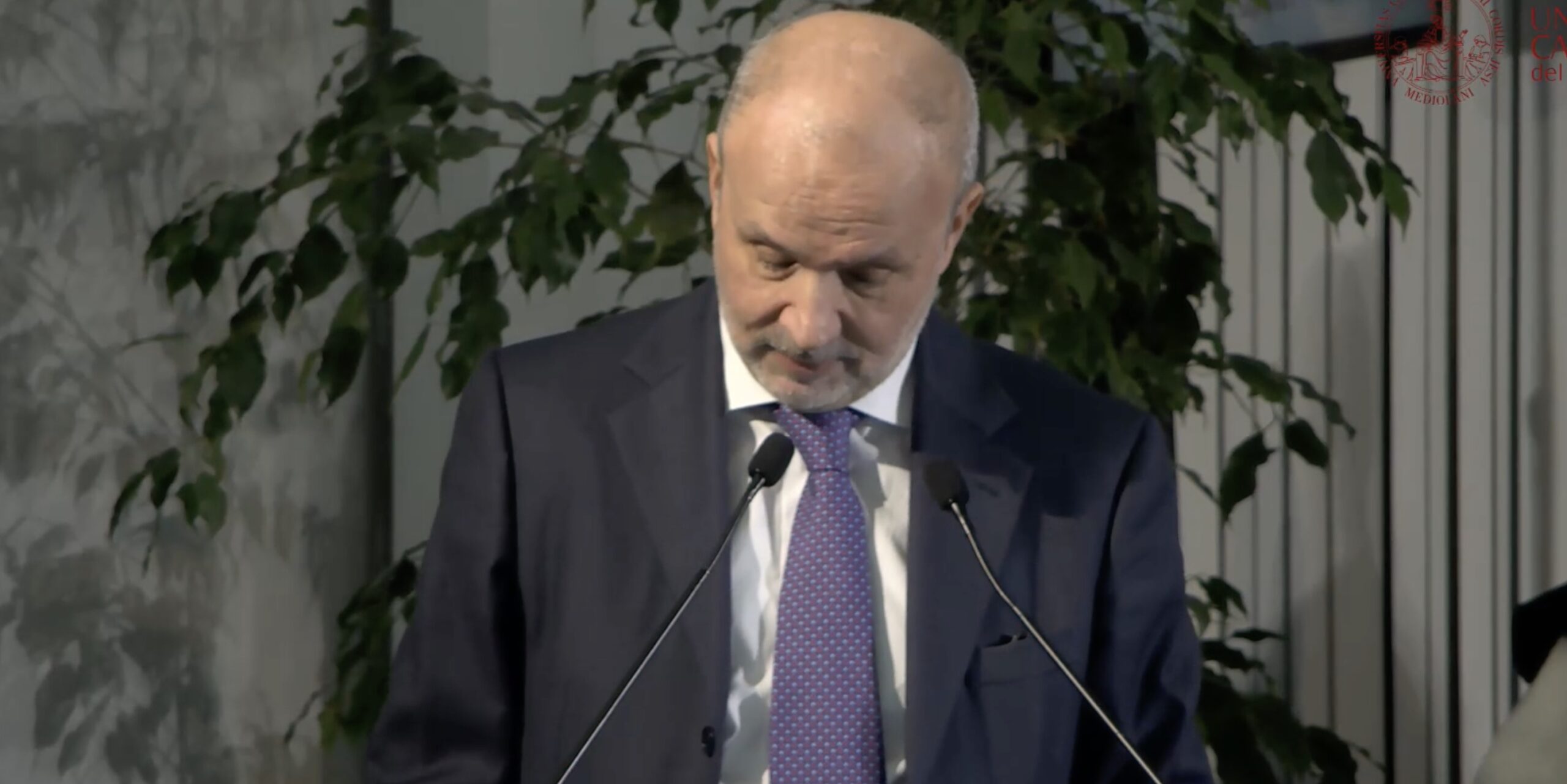
Schillaci: “Intollerabile che l’accesso alle cure dipenda dal Cap o dal reddito. Difendere universalismo e gratuità del SSN”

Richiamo globale su latte artificiale e altri prodotti per neonati per tossina da Bacillus cereus

La Dirigenza delle Professioni Sanitarie: oltre il vicolo cieco di vent'anni di penalizzazioni, un investimento necessario per la salute pubblica

Prevenzione melanoma. Via libera del Senato al testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi

Al via la riforma del Servizio sanitario nazionale. Nascono gli ospedali di terzo livello e quelli "elettivi" senza Pronto Soccorso. Riordino disciplina per medici di famiglia e pediatri

Prevenzione melanoma. Via libera del Senato al testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi

I dieci motivi per cui gli Infermieri con Laurea Magistrale ad Indirizzo Clinico dovrebbero afferire alla Dirigenza

Paziente ucciso da un altro paziente in reparto di Psichiatria. “L’assassino era pericoloso e in attesa di trasferimento in Rems”

Inibitori di Pompa Protonica. Aifa introduce una nota che ne regola la prescrivibilità
