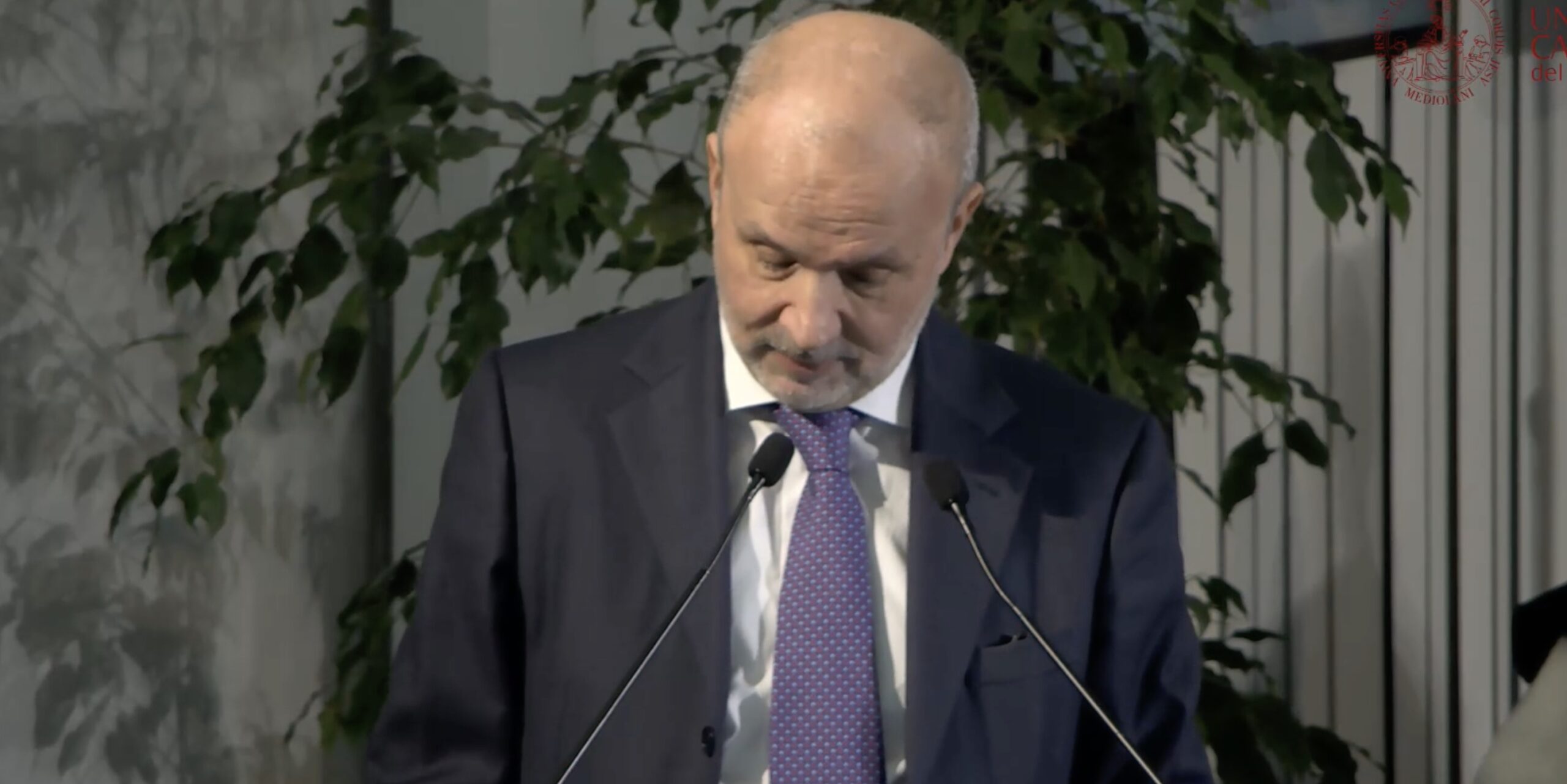Gentile Direttore,
da tempo medito sull’evoluzione della nostra professione, sulle linee guida e sulle attenzioni che il medico dovrebbe avere ed attuare nei confronti del paziente o che altro si voglia chiamare. In effetti molti decenni fa questo ruolo era un ruolo preminente del medico di famiglia (se ce l’aveva nel suo bagaglio umano!), ma ora lo ritengo impossibile anche per i “poveri” medici di assistenza primaria, chiamati a tutt’altro che alla vicinanza e al conforto del paziente, sommersi da carte e burocrazie. Pullulano allora convegni, meeting, incontri web che mirano a migliorare il rapporto medico-paziente, per rendere quest’ultimo partecipe, co-attore, responsabile della sua cura. Tutte cose giuste e futuro (o già presente?) della nostra professione.
Dimentichiamo però che nell’ordinamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, non esiste l’obbligo di corsi ed esami quali ad esempio Comunicazione o Psicologia clinica. E forse a molti medici ciò non interessa! Ricordo alla perfezione ad un meeting su questo tema, la posizione di un collega “organicista” che riteneva che il suo compito fosse far funzionare bene il corpo del paziente, che, se avesse manifestato il bisogno di dialogo, comprensione o confronto, doveva rivolgersi a psicologi e psicoterapeuti. Così, in pratica, il medico si vede formato su fatti scientifici per quasi tutto il suo percorso di studi, non venendo praticamente mai a contatto con il suo compito personale di gestire il rapporto con i pazienti, la capacità di ascoltare, comunicare, di spiegare, di sostenere e magari di evitare di ergersi a “laureato di fronte al popolo!”.
Perché allora penso che tutte queste caratteristiche importanti assomiglino spesso a delle grossolane ipocrisie? Infatti chi può negare l’importanza e il valore di quanto sopra, ma nella pratica? L’ipocrisia giace nell’orologio al polso, che controlla al secondo il tempo a disposizione della nostra professione, in cui tutte queste cose non ci potranno mai stare dentro per come fino ad oggi è ed è stato (anche in tempi di “vacche grasse”) concepito il servizio sanitario. Per altro, di questi tempi non mi sentirei di fare differenze tra pubblico e privato, in quanto, ovunque, quello che conta è l’indice di performance, la prestazione. Quindi resta al massimo la capacità di sorridere e la gentilezza nell’accogliere chi soffre, che non è un problema di tempo, ma si chiama empatia, e questa uno in genere ce l’ha o non ce l’ha.
Come è possibile durante una visita (peggio se di controllo) esercitare tutte queste utili e doverose capacità virtuose con un paziente, che ci vede avere tempi di prestazione variabili tra i 10 e i 30 minuti (40 per chi è più fortunato), dovendo aderire a doverose burocrazie che rubano inesorabilmente la parola, ma soprattutto lo sguardo (ormai magnetizzato dallo schermo del PC) al nostro interlocutore, che chiede a noi aiuto!
Come fare a prendersi il tempo per comunicare un qualcosa che non sia una semplice lista di farmaci, cercando invece di comunicare diagnosi e cura coi tempi dovuti e magari agire per rinforzare l’aderenza terapeutica? Cosa fare se poi aleggia lo spettro del consenso informato? Una mia collega, qualche anno fa, partecipando ad uno studio epidemiologico osservazionale non interventistico, sui pazienti in sua gestione, si è vista chiedere indietro un orario di servizio gratuito da rendere pari a mezzora per consenso informato di paziente dalla sua azienda (tempo ovviamente macroscopico per il fatto specifico). Quindi l’azienda sapeva benissimo quali sarebbero i tempi da dedicare a un paziente, ma applicandoli a “condanna” della collega a suo interesse. Chi può pensare di essere visitato in meno di 15 minuti in questo modo: ipocrisia. E quanti consensi informati vengono firmati nella sala pre-operatoria, come una fastidiosa burocrazia di nessun valore, ma che evita il rischio di una condanna penale. È capitato più volte anche a me, come ad altri… “Firmi per favore…è il consenso informato!”: 2-3 pagine di cui si è parlato forse sì e forse no! Affidamento totale, salvi rari casi.
Quindi cosa fare? Nulla! Il sistema non permetterà mai cambiamenti in questo momento. Ne forse è interessato, più coinvolto a quantificare prestazioni e relativi indici, che gradimento dell’assistenza, vista come accoglienza, comunicazione o ascolto. Ci resta almeno il tentativo di esplicare e fare nostra la consapevolezza di tale carenza, di prendere atto di ipocrisie di cui molti si fanno inutilmente gonfi e magari provare a rispolverare un po’ di empatia, così arrugginita e inviluppata negli ingranaggi della nostra medicina attuale, solo per riuscire a mettere i nostri pazienti a loro agio, sentendosi ascoltati e presi veramente in carico, non da un protocollo, ma…da un medico che è anche una persona.
Gianniantonio Cassisi
Medico Reumatologo SAI e Referente Sindacale SMI-FESPA Veneto