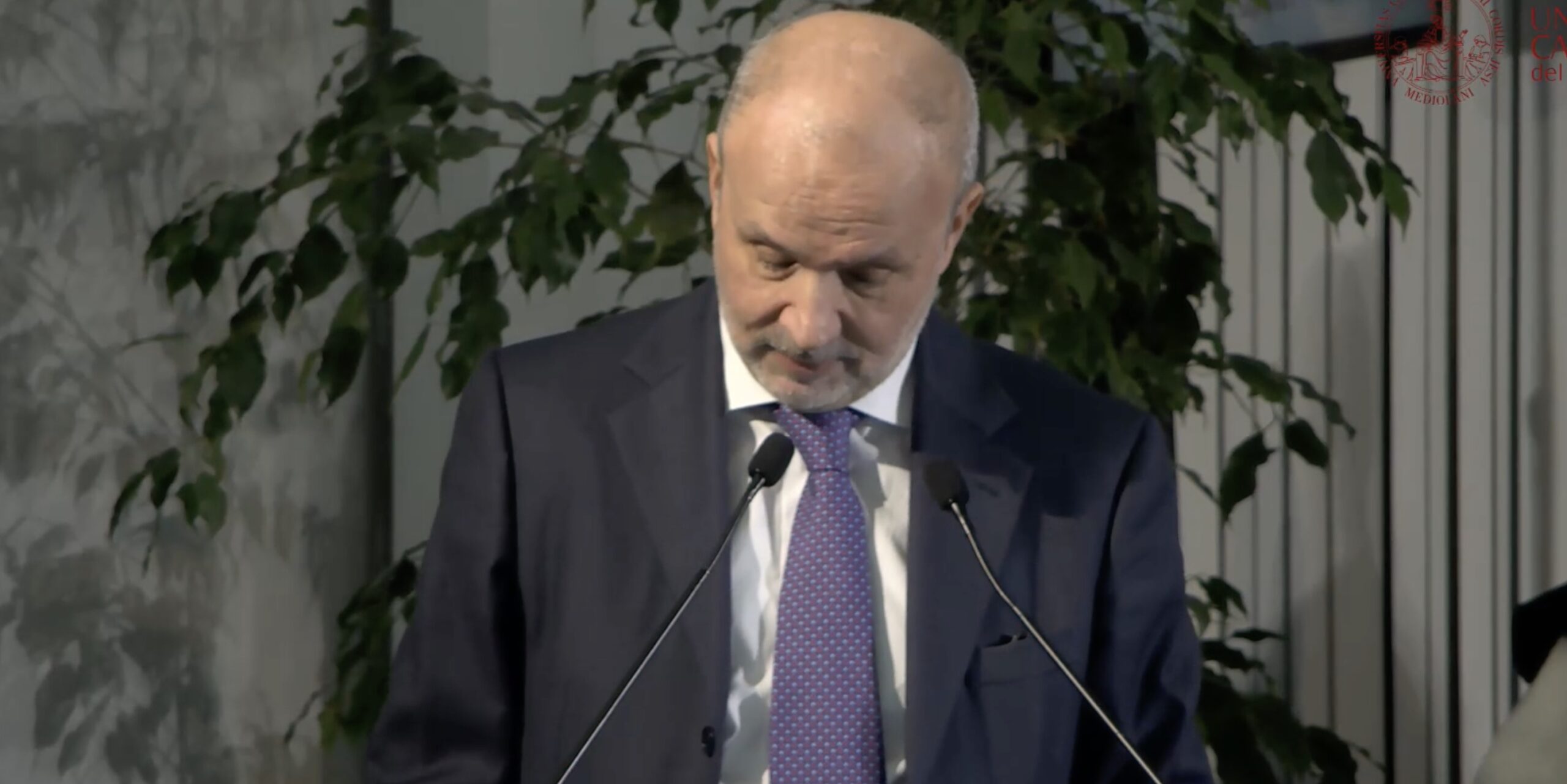Gentile Direttore,
questi giorni si è tornati a parlare molto di mobilità sanitaria tra Regioni da quando il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha lanciato un grido di allarme puntualmente ripreso da Qs: “La mobilità sanitaria interregionale è in forte aumento e sta mettendo sotto pressione il sistema. Serve un grande patto nazionale, perché questa situazione non è sostenibile”. Segue una distinzione cruciale: da un lato, l’eccellenza delle “prestazioni ad alta complessità” che giustamente attirano pazienti da tutta Italia; dall’altro, l’aumento insostenibile della “domanda di prestazioni di bassa complessità”. Chiusura: “Non è solo una questione economica non esistono infermieri e professionisti infiniti. Il sistema rischia di non reggere”. Sempre dall’articolo di Qs emerge come il segnale sia condiviso dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal Ministro Schillaci. Stanno uscendo i primi interventi di commento all’intervento di Di Pasquale e di proposta di possibili rimedi e forse può essere utile la condivisione di una serie di dati e di informazioni sul fenomeno in modo da porre le basi per un percorso difficile, ma possibile, per un miglior governo della mobilità sanitaria. Seguirò una seconda parte sulla interpretazione dei fenomeni e sui possibili interventi correttivi.
Le fonti di dati e analisi sulla mobilità sanitaria
La fonte più aggiornata e analitica sulla mobilità sanitaria è rappresentata dalla Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Agenas) che ha pubblicato due rapporti sulla mobilità sanitaria in Italia relativi al 2024 (dati 2023) e 2023 (dati 2022) che circola in una versione completa con i dati analizzati a livello di ciascuna Regione e in una versione sintetica simile a quella del 2024. L’Agenas riporta poi i dati della mobilità sanitaria aggiornati al 2023 con i dati annuali dal 2018 in quattro sezioni del suo portale statistico: quella sulla mobilità sanitaria con dati solo sui ricoveri; quella sui risultati economici della mobilità pure riservata ai soli ricoveri, quella con il Focus della Mobilità per Patologie Oncologiche e Muscoloscheletriche e quella con i Profili Sanitari delle Regioni e delle Province Autonome che dedica alcune tabelle alla mobilità ospedaliera (le stesse della sezione omonima) e alla mobilità passiva per le prestazioni ambulatoriali. Un’altra fonte importante è il Rapporto GIMBE sulla mobilità sanitaria di cui sono uscite due edizioni, quella 2025 con i dati relativi al 2022, e quella 2024 con i dati sui flussi 2021.
La fonte delle elaborazioni dell’Agenas sulla mobilità per ricoveri è rappresentata dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). Nel Rapporto sulla mobilità sanitaria in Italia 2024 sono molto ben descritti i criteri di inclusione e di analisi dei ricoveri in mobilità interregionale. Ai fini di questo articolo è sufficiente ricordare che vi sono inclusi tutti i ricoveri a carico della Regione di provenienza e che la coorte di ricoveri esaminata viene distinta a seconda del tipo di mobilità:
- mobilità apparente: ricoveri effettuati nella regione di domicilio del paziente, quando questa non coincide con la regione di residenza;
- mobilità casuale: ricoveri effettuati in urgenza;
- mobilità effettiva: componente sulla quale la regione potrebbe intervenire per contrastare il fenomeno della mobilità. Questa è ulteriormente suddivisa in: ricoveri con DRG di alta complessità, ricoveri con DRG di media o bassa complessità e ricoveri classificati come DRG a rischio di inappropriatezza.
La mobilità effettiva viene poi esaminata anche in base alla distanza tra il luogo di residenza e il luogo di cura. Si parla di mobilità di confine quando il ricovero avviene in una regione confinante. Nella lettura ed eventuale comparazione e citazione dei dati Agenas meglio sempre esplicitare la tipologia di ricoveri di mobilità presi in considerazione (totale, effettiva, di confine, ecc.). Tutte le analisi più di dettaglio sono fatte con riferimento alla sola mobilità effettiva che equivalgono a 2,316 miliardi di scambi nel 2023 su un totale di 2,880.
Per le elaborazioni dei dati sulla specialistica ambulatoriale erogata in regime di mobilità Agenas utilizza i dati del cosiddetto file C e classifica le prestazioni nelle categorie FARE di I livello (Visite, Riabilitazione, Diagnostica, Laboratorio, Terapia). Nel Rapporto 2024 vengono fatte delle analisi anche in base alle cinque prime categorie per livello di costo: genetica/citogenetica, radioterapia, chirurgia ambulatoriale maggiore, risonanza magnetica e medicina nucleare.
Le analisi di GIMBE utilizzano altre due fonti per la quantificazione e descrizione della mobilità sanitaria: i dati del riparto del Fondo Sanitario Nazionale che ogni anno quantificano i debiti e i crediti legati a tutte le voci della mobilità sanitaria (vedi dopo) e i dati dei Modelli M che ogni anno le Regioni si scambiano coi dati della mobilità relativi ai cosiddetti flussi standard (tra parentesi il loro peso economico percentuale stimato da GIMBE per il 2022): ricoveri (69,9%), specialistica ambulatoriale (15,9 %), somministrazione diretta di farmaci (9,3%); farmaceutica (2,0%); trasporti con elisoccorso ed ambulanza (1,4%), medicina generale (0,8%) e cure termali (0,7%).
La lettura combinata dei documenti Agenas e GIMBE fornisce un quadro molto utile di riferimento che necessita per una lettura più consapevole della conoscenza delle regole che di seguito verranno adesso ricordate.
Le regole della mobilità sanitaria
Premesso che qui si parla solo di mobilità interregionale, le regole tecniche che governano il mondo della mobilità sanitaria sono riportate in un Accordo che ogni anno viene approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo formalmente approvato fa riferimento all’anno 2023, ma sulla stessa base le Regioni si sono già scambiate i dati 2024. Tra le altre cose le regole tecniche riportano le tariffe e i controlli di appropriatezza sulla attività di ricovero. Le tariffe per l’attività di ricovero, una volta specifiche per la mobilità, sono oggi le tariffe introdotte dal DM 18 ottobre 2012. Alle medesime tariffe viene applicata una remunerazione aggiuntiva, nel rispetto dell’art. 2 comma 4 del citato DM, per la lista dei ricoveri per i quali è stato riscontrato che la tariffa è insufficiente alla copertura dei costi legati all’impiego delle protesi o dei dispositivi medici. Per le Aziende miste è previsto un incremento pari al 7%. Inoltre, è prevista una remunerazione specifica per i ricoveri degli Ospedali pediatrici, che prevede un incremento delle tariffe del DM 2012 per una lista di 119 DRG riconosciuti di alta specialità per 10 Istituti pediatrici monospecialistici (incremento del 20%) e per 4 strutture pediatriche che svolgono una attività di alta specializzazione nel settore pediatrico (incremento del 15%).
Quanto vale “veramente” la mobilità sanitaria
Per capire quanto incide la mobilità sanitaria sui bilanci delle sanità regionali lo si capisce bene dal Riparto annuale del Fondo Sanitario. In questo riparto il finanziamento previsto per ciascuna Regione e Provincia Autonoma viene corretto in base ai dati di mobilità dell’anno prima per cui le Regioni creditrici con un saldo di mobilità attivo hanno ogni anno un anticipo di quanto produrranno per le altre Regioni. Ovviamente vale l’opposto per le Regioni debitrici con un saldo negativo. Se si entra nel dettaglio le cose si complicano un po’ come vediamo se prendiamo l’ultimo riparto, quello del 2024, in cui si quantifica l’incidenza dei saldi di mobilità sul fondo indistinto (al netto cioè dei fondi finalizzati). Vediamo in fondo alla infinita Tabella C che sta in tre pagine che le Regioni si scambiano per effetto della mobilità 5,037 miliardi di euro su un fondo indistinto complessivo di 128,6 miliardi (Tabella B). Se abbiamo la pazienza (ce ne vuole tanta) di vedere le voci che confluiscono in quei 5 miliardi di dare-avere scopriamo che la mobilità sanitaria utilizzata per arrivare a quella cifra sono: 4,6 miliardi scambiati nel 2023 in base ai flussi standard, 324 milioni per il conguaglio degli stessi scambi di mobilità del 2022 utilizzati nel Riparto dell’anno precedente, 10 milioni legati ai cosiddetti disabili cronici (si tratta di persone che si sono trasferite da una Regione all’altra per essere assistite in regime residenziale) più qualche altro milione legato a specifiche partite (plasmaderivati, ricerca e reperimento di cellule staminali, ecc.).
Quindi le Regioni che producono “in eccesso” si trovano già finanziate in partenza e quelle “che non ce la fanno” a essere autonome sono sottofinanziate in partenza. Si tratta di un meccanismo che contribuisce a rendere strutturali i flussi di mobilità più consistenti e cioè quelli tra il Sud che manda e il Nord che riceve.
L’effetto dei privati sull’impatto economico dei saldi di mobilità sulle Regioni
Tradizionalmente l’impatto sui bilanci regionali dei flussi di mobilità si calcola sulla base del saldo attivo o passivo riportato nel Riparto annuale del Fondo sanitario (vedi ad esempio le elaborazioni GIMBE) oppure sulla base del saldo relativo ai ricoveri e alle prestazioni ambulatoriali. Prendiamo il caso delle Marche che nel riparto 2024 hanno avuto sottratti 53,7 milioni che derivano dai 124,6 milioni di crediti e i 178,3 milioni di debiti (dati che abbiamo visto influenzati da più partite, ma gli scambi per ricoveri e prestazioni ambulatoriali sono quelle più importanti). Ma di quei 124,6 milioni di crediti una parte consistente viene rigirata ai privati delle Marche che hanno erogato buona parte delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali in mobilità attiva negli anni 2023 e 2022 (ricordiamoci del conguaglio relativo a questo anno). Quindi di fatto il saldo negativo in termini di risorse destinabili ai LEA per la Regione non è 53,7, ma 53,7 più la mobilità attiva “rigirata” ai privati. Per la sola attività di ricovero del 2023 la Regione Marche ha rigirato ai privati 40 milioni (su un totale di 83) che assieme a circa il 40% della mobilità attiva di 11 milioni per le prestazioni ambulatoriali portano a stimare a oltre 100 milioni la cifra che la Regione Marche sottrae ai suoi 3.273 milioni di fondo indistinto “di spettanza” per l’erogazione “in proprio” dei LEA per effetto dei saldi di mobilità calcolati al netto del contributo dei privati.
Ovviamente quello che vale per le Marche vale per le altre Regioni. Si tenga conto che in base ai dati Agenas 2023 su 2,881 di mobilità attiva per l’attività di ricovero 1697 (il 60%) viene rigirato ai privati e quindi sottratti alla erogazione “in proprio” dei LEA da parte delle Regioni. A questi vanno aggiunte le prestazioni ambulatoriali erogate in mobilità attiva dai privati.
Nella seconda parte di questo articolo si esamineranno più nel dettaglio le dinamiche sottostanti ai flussi di mobilità e le possibilità di meglio governarle.
Claudio Maria Maffei