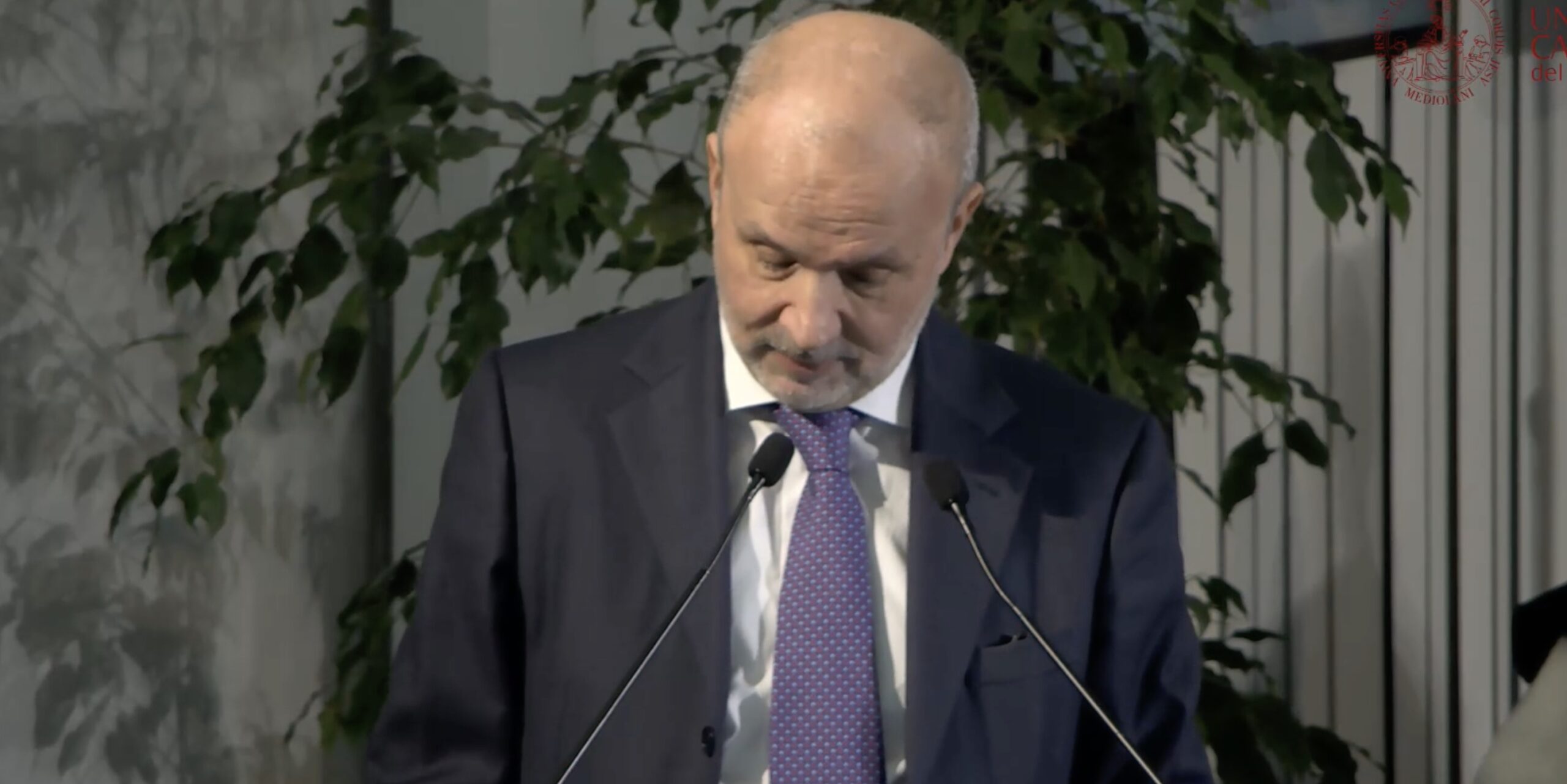Gentile Direttore,
Nel settembre 2025, nell’aggiornamento della lista delle medicine essenziali, l’OMS ha finalmente rimosso la specifica che dal 2005 accompagnava i farmaci per l’aborto, mifepristone e misoprostolo: “only where legally permitted and culturally accettable”. Una notazione incomprensibile, sia perché è ovvio che l’uso dei farmaci (non solo quelli per l’aborto) è legato al rispetto di eventuali specifici quadri normativi, relativi alle legislazioni dei singoli paesi, sia perché è ben chiaro da tempo che questa raccomandazione non è supportata da alcun dato di evidenza scientifica.
La decisione dell’OMS ci mostra indirettamente quanto le scelte di politica sanitaria nel campo della salute riproduttiva siano fortemente condizionate dal clima culturale e dall’impostazione ideologica dei governi; ciò è particolarmente evidente nel nostro Paese, dove la regionalizzazione della sanità pubblica ha reso il diritto alla salute riproduttiva ostaggio dei preconcetti ideologici, etici, religiosi di chi governa le Regioni, generando inaccettabili disparità e diseguaglianze sul territorio nazionale.
Ne sono un esempio le ostilità e le limitazioni all’accesso all’aborto farmacologico e l’incomprensibile resistenza alla deospedalizzazione di questa procedura, ammessa ormai 5 anni fa dall’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali. Incomprensibile perché cozza con un principio fondamentale delle politiche di salute pubblica, che è quello dell’appropriatezza delle prestazioni, al quale il governo ci richiama costantemente: a parità di sicurezza ed efficacia, e se la persona assistita lo consente, DEVONO essere privilegiati i setting assistenziali che richiedono un minor impegno – economico e organizzativo – per il sistema sanitario.
Eseguire la procedura in consultorio o in un poliambulatorio, consegnando alle donne il secondo farmaco da assumere a casa, e limitare i ricoveri ospedalieri ai soli casi in cui vi sia una specifica richiesta della donna o in cui vi sia la necessità di un attento monitoraggio clinico (ad esempio per la presenza di particolari patologie) dovrebbe essere la norma, esattamente come accade nella quasi totalità degli altri Paesi. Il ricovero in ospedale dovrebbe dunque essere un’eccezione: perché non aumenta la sicurezza della procedura, perché aumenta il rischio di contrarre infezioni (lo sapevamo già, ma la pandemia ce lo ha confermato), perché evita uno spreco inaccettabile di risorse pubbliche.
Eppure, a ben cinque anni dall’aggiornamento delle linee di indirizzo, l’ABORTO SENZA RICOVERO è una realtà solamente in due regioni: il Lazio, dove si pratica dal 2021, e l’Emilia Romagna, dove si pratica dal gennaio 2025.
La Toscana, dove il regime ambulatoriale è ammesso dal 2019, costituisce un caso particolare: in primo luogo perché non ammette la possibilità di praticare l’IVG farmacologica in consultorio, sulla base di un’interpretazione incomprensibilmente rigida dell’art. 8 della legge 194, sulla base della quale la Regione ha rigettato l’interpretazione data dal Ministero della salute nel 2020. In secondo luogo, perché il protocollo operativo toscano impone alle donne almeno tre accessi nella struttura sanitaria: le donne devono recarvisi per prendere il primo farmaco, devono tornarvi due giorni dopo per prendere il secondo farmaco, rimanendo sotto osservazione (in ambulatorio!) per qualche ora, e infine devono tornarvi per un controllo post-procedura.
Tutto ciò non aumenta la sicurezza della procedura ma, probabilmente, tradisce una diffidenza in proposito, che non ha riscontri di evidenza scientifica, ma che ha portato le/gli estensori del protocollo a trasferire modalità operative ospedaliere in un contesto ambulatoriale, con la ovvia conseguente penalizzazione delle donne: per loro, rispetto al ricovero in DH, aumenta il disagio di avere una poltrona e non un letto, oltre ad aumentare il rischio di sanguinamento o di malessere in itinere, una volta “dimesse” dall’ambulatorio.
Si deve notare, infine, che tanti passaggi nella struttura sanitaria fanno lievitare i costi: anziché circa 72 euro di rimborso del costo dei farmaci, il rimborso in Toscana ammonta a 500 euro. Uno spreco di risorse inaccettabile.
Perché in più di cinque anni le Regioni non si sono adeguate per permettere alle donne che scelgono la procedura farmacologica di eseguirla in consultorio, prendendo poi il secondo farmaco, il misoprostolo, a domicilio?
Non per motivi di sicurezza: tutta la letteratura scientifica dimostra infatti che il “self-management” dell’aborto farmacologico non aumenta i rischi per le donne, anzi, riduce l’incidenza di visite di controllo inutili.
Non per motivi organizzativi: qualunque ambulatorio o qualunque stanza di un consultorio è una sede adatta per eseguire tale procedura, che richiede solo un lungo ed accurato counselling.
Rimangono solo le motivazioni ideologiche: l’idea – falsa e offensiva per le donne – che la procedura farmacologica banalizzi l’aborto e che le donne, fragili e irresponsabili, non incontrando ostacoli siano più propense ad interrompere gravidanze non volute; l’idea che le donne debbano essere sostenute e che non siano in grado, per la loro naturale fragilità, di gestire in prima persona una procedura medica; la paura dei medici di perdere il potere nella relazione con le donne, che ostinatamente vengono indicate come “pazienti”.
Per queste ragioni, la campagna “ABORTO SENZA RICOVERO”, lanciata in tutte le Regioni dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica aps, ha un significato che travalica la richiesta di non sperperare risorse preziose sulla base di pregiudizi ideologici e religiosi: è una battaglia per il riconoscimento del diritto di scelta, ed è un passo importante verso una sanità pubblica che abbia le persone al centro e che ne promuova realmente l’“empowerment”.
Anna Pompili
Ginecologa, consigliera generale Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica aps