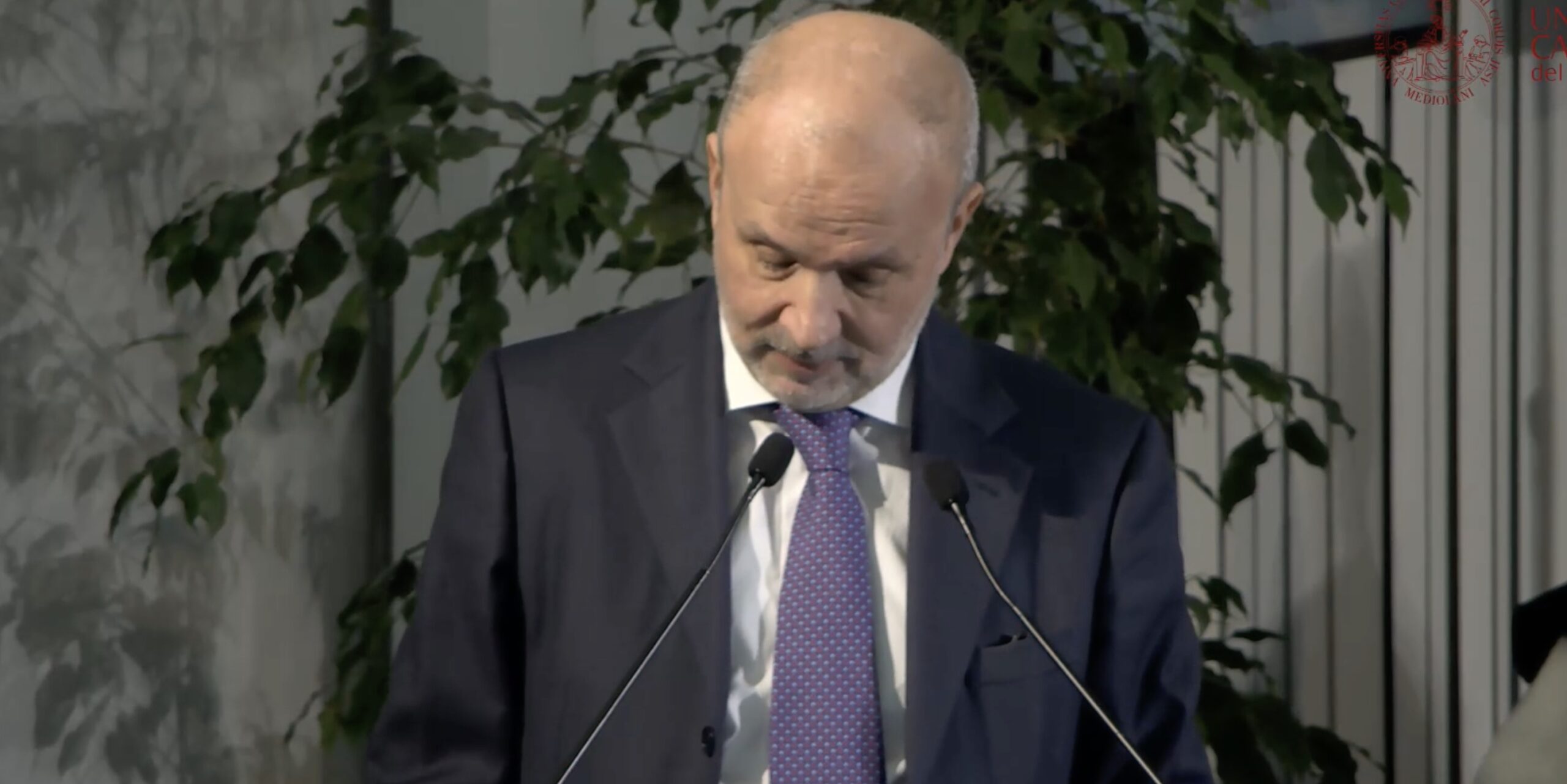L’informazione sanitaria influenza profondamente la percezione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nessun altro ambito tocca la vita quotidiana delle persone in modo così diretto: nascere, ammalarsi, guarire, morire, ogni fase dell’esistenza attraversa la sanità pubblica.
Eppure, ciò che i cittadini sanno (o credono di sapere) sul sistema sanitario deriva più dai media che dall’esperienza diretta. Per questo è necessaria una riflessione articolata e documentata su come viene raccontata oggi la sanità pubblica: quali storie si sceglie di raccontare, quali si tacciono e con quali parole si usano per raccontare. Dietro ogni notizia sanitaria, infatti, non c’è solo un fatto: c’è una rappresentazione della realtà che condiziona fiducia, comportamenti e persino decisioni politiche.
E allora dobbiamo provare a passare dalle percezioni della realtà a fatti misurabili, sfida complessa in un periodo in cui le percezioni contano più delle evidenze. E la sanità pubblica, come ogni grande istituzione collettiva, è costantemente sotto il fuoco delle opinioni, spesso basate su esperienze episodiche o racconti amplificati dai social.
Un sondaggio IPSOS del 2023 mostrava che il 68% degli italiani ritiene la sanità pubblica “in declino”, ma quando si chiede loro di valutare la propria esperienza personale, oltre il 70% dichiara di essere rimasto soddisfatto delle cure ricevute. Il paradosso è evidente: la narrazione collettiva è più negativa della realtà vissuta.
Eppure i dati oggettivi raccontano un’altra storia: secondo l’OCSE Health Statistics 2024, l’Italia spende per la sanità circa il 9,3% del PIL, meno della Germania (12,7%) o della Francia (11,1%), ma registra un’aspettativa di vita tra le più alte d’Europa (83,6 anni).
Il nostro sistema garantisce copertura universale, accesso gratuito o quasi alle cure complesse, e una rete di medicina territoriale tra le più diffuse.
Un esempio significativo è quello del programma di screening oncologico (mammella, colon-retto, cervice) che ha raggiunto nel 2023 oltre 12 milioni di cittadini, con una diagnosi precoce che ha salvato decine di migliaia di vite.
Spostarsi dalle percezioni ai fatti misurabili significa imparare a leggere il sistema nella sua interezza, distinguendo il fisiologico dal patologico, la crisi strutturale dal disservizio episodico.
E ricordiamoci sempre che i media operano secondo logiche di visibilità. Nel campo sanitario, ciò genera una distorsione sistematica: le cattive notizie “vendono”, le buone no.
Nel 2022, l’Osservatorio News Sanità dell’Università di Bologna ha analizzato oltre 3.000 articoli sanitari: il 72% conteneva toni negativi o scandalistici, solo il 9% positivi: un errore medico diventa prima pagina; una campagna vaccinale ben riuscita passa inosservata. La cronaca amplifica il caso di un errore di somministrazione vaccinale in una ASL, ma non dà spazio alla copertura media del 95% raggiunta in età pediatrica nello stesso anno, una delle più alte d’Europa. Raccontare solo il negativo genera una percezione distorta: il cittadino si convince che tutto vada male, anche quando i dati dimostrano il contrario. Una informazione matura dovrebbe invece restituire equilibrio: denunciare ciò che non funziona, ma anche valorizzare ciò che funziona bene.
Inoltre, spiace dirlo, c’è anche una disparità nel modo in cui pubblico e privato vengono raccontati e questo genera un bias narrativo. Infatti, non è una affermazione azzardata, quando un ospedale pubblico ha un disservizio, è “il fallimento del sistema”; quando accade in una struttura privata, è “un caso isolato”.
Potremmo fare decine di esempi in cui un grave errore diagnostico in una clinica privata ha avuto un’eco minima, mentre un caso analogo in un importante ospedale pubblico ha dominato per settimane i titoli nazionali. Il bias narrativo, l’idea implicita che il privato sia sinonimo di efficienza e il pubblico di spreco, orienta troppo spesso la percezione collettiva. Ovviamente – sia chiaro – non si vuole affermare il contrario in queste considerazioni, ma solo evidenziare che la realtà è più complessa: secondo AGENAS (Rapporto 2024), i tassi di mortalità post-operatoria e di riammissione ospedaliera risultano analoghi o migliori nelle strutture pubbliche rispetto a quelle private accreditate, soprattutto nei casi di emergenza.
La narrativa, tuttavia, continua a premiare la semplificazione: il “caso negativo” del pubblico vale più del “risultato positivo” complessivo.
Sappiamo anche che molte critiche alla sanità pubblica nascono da visioni valoriali diverse. Da un lato chi vede la salute come diritto universale; dall’altro chi la considera un servizio da acquistare. Un ospedale pubblico non può scegliere i pazienti né massimizzare i ricavi riducendo le cure più costose: la sua missione è garantire equità. Per questo un pronto soccorso pubblico accoglie tutti, anche chi non paga o non ha documenti.
Dietro la retorica dell’“inefficienza pubblica” spesso si nasconde un conflitto ideologico: chi misura il valore della sanità in termini di profitto e chi lo misura in termini di giustizia sociale.
Rendere esplicito questo conflitto aiuta a capire che non si tratta solo di amministrazione, ma di etica pubblica. Dobbiamo chiaramente mettere alla prova la coerenza tra libertarismo economico e tutela dei diritti.
Pensiamo a come la pandemia di COVID-19 abbia fornito un test drammatico. Nei Paesi dove la sanità è più privatizzata, come gli Stati Uniti, la crisi ha messo in luce le disuguaglianze: milioni di persone senza assicurazione, ospedali sovraccarichi, vaccini distribuiti in base alla capacità di pagamento. In Italia, nonostante carenze e difficoltà, ogni cittadino ha avuto accesso ai vaccini gratuitamente e in tempi comparabili, indipendentemente dal reddito.
Questo è il punto di coerenza etica: la salute non può essere merce. Il mercato regola la concorrenza, ma non la dignità. Un modello sanitario che subordina le cure al reddito è incompatibile con la Costituzione e con i principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 e 32). E chi difende la sanità pubblica difende, in ultima analisi, l’idea di una comunità solidale.
Fare emergere la complessità strutturale dietro i problemi di efficienza è quindi anche un dovere perché le inefficienze del sistema pubblico non nascono dal nulla. Le liste d’attesa, la carenza di medici, il sovraffollamento dei pronto soccorso sono sintomi di problemi strutturali: sotto finanziamento, vincoli assunzionali, scarsa integrazione tra territorio e ospedale.
Tra il 2010 e il 2022, la sanità italiana ha perso oltre 45.000 operatori, tra medici, infermieri e tecnici, a causa del blocco del turnover e dei tagli lineari.
In parallelo, la popolazione over 65 è aumentata di oltre 2 milioni di persone.
È evidente che il sistema è sotto stress non per cattiva volontà, ma per disequilibrio strutturale e probabilmente per una scarsa capacità di riequilibrare gli standard territoriali: ad esempio i parametri per i posti letto per la post acuzie sono dimensionati su una percentuale di cronicità molto inferiore alla attuale.
Tuttavia, molte regioni hanno sperimentato soluzioni efficaci:
• In Lombardia, l’introduzione del sistema “Agenda Unica” ha ridotto del 25% i tempi d’attesa per diagnostica per immagini.
• In Emilia-Romagna, la sanità digitale ha consentito la prenotazione online e il monitoraggio integrato dei pazienti cronici.
• In Toscana, il progetto “Infermiere di Famiglia” ha diminuito i ricoveri impropri.
• Nel Lazio alcuni Ospedali di Comunità hanno ridotto gli accessi in Pronto Soccorso.
Raccontare la sanità pubblica senza spiegare questa complessità quindi significa tradire la realtà. Bisogna riflettere sul valore universale del modello pubblico, perché la sanità pubblica è “ancora” un patrimonio di civiltà. Dal 1978, con la legge 833, l’Italia ha scelto un modello universalistico basato sull’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.”
In Europa, solo pochi Paesi, come Svezia e Spagna, possono vantare un livello di universalità simile e questo questo modello ha resistito a crisi economiche e pandemiche, dimostrando resilienza e capacità di adattamento.
Pensiamo ad esempio al programma di trapianti d’organo del SSN che è oggi tra i migliori al mondo, con tassi di successo e sicurezza ai vertici europei, e interamente pubblico. Ogni giorno centinaia di interventi salvano vite senza che nessuno debba “pagare” la possibilità di sopravvivere.
Difendere il pubblico significa difendere questo principio: che la vita non ha prezzo e la cura non è un privilegio.
E’ in sostanza necessario soffermarsi su una riflessione sul punto di vista e sulle fonti di informazione, perché non tutte le fonti interne al sistema sanitario raccontano la verità intera. Sappiamo bene che molte denunce di “malasanità” provengono da operatori frustrati, sindacati o cittadini isolati, la cui esperienza è reale ma parziale. Il compito di chi si occupa di informazione è anche contestualizzare, non amplificare. Un racconto onesto deve includere la voce di chi lavora, ma anche quella di chi gestisce, di chi pianifica, di chi misura i risultati. Perché la complessità del sistema richiede pluralità di sguardi.
Ricordiamoci che durante la crisi pandemica, alcuni articoli denunciavano “ospedali al collasso” sulla base di poche testimonianze, mentre i dati regionali mostravano tassi di saturazione sotto l’80% grazie al lavoro di riconversione dei reparti. Senza verifica, l’informazione diventa disinformazione, quando invece l’informazione in ambito sanitario ha un compito civico: ricostruire fiducia, non alimentare sospetto. Infatti ogni informazione sulla sanità pubblica è un atto politico e morale. Significa decidere se promuovere la fiducia o la sfiducia, la coesione o la frammentazione.
Informare correttamente non significa censurare i problemi, ma renderli comprensibili, distinguendo tra colpa e causa, tra errore e limite di sistema.
Significa anche porsi domande di principio: Quale visione di società vogliamo trasmettere? Vogliamo un sistema sanitario accessibile a tutti o solo a chi può permetterselo? Siamo disposti a difendere la sanità pubblica anche quando è imperfetta, perché rappresenta un diritto, non un servizio commerciale?
Le risposte devono sempre tener conto che la qualità dell’informazione, anche in ambito sanitario, è in sostanza un misuratore della qualità della democrazia.
Sappiamo bene che la sanità pubblica non è perfetta, ma è un patrimonio da difendere. L’informazione che la racconta ha il potere di rafforzarla o indebolirla. e proprio per questo serve un a informazione capace di unire rigore e sensibilità, di criticare senza distruggere, di costruire fiducia invece di paura.
Raccontare la verità nella sua complessità è oggi il più grande servizio pubblico che si possa rendere.
Angelo Aliquò
Direttore Generale AO san Camillo Forlanini
Bibliografia
1. OCSE, Health Statistics 2024, Paris: OECD Publishing.
2. Ministero della Salute, Relazione sullo stato sanitario del Paese 2023, Roma.
3. AGENAS, Rapporto annuale sulla qualità e sicurezza delle cure 2024, Roma.
4. ISTAT, Annuario statistico italiano 2023, sezione Sanità e salute.
5. OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), World Health Report 2023, Geneva.
6. IPSOS Italia, Percezioni e fiducia nel SSN: indagine nazionale 2023.
7. Osservatorio News Sanità, Università di Bologna, La rappresentazione mediatica della sanità italiana 2022.
8. Fondazione GIMBE, Rapporto sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale 2024.
9. AIFA, Rapporto nazionale sull’uso dei farmaci 2023.
10. Corte dei Conti, Relazione sul coordinamento della finanza pubblica 2024 – Sezione Sanità.