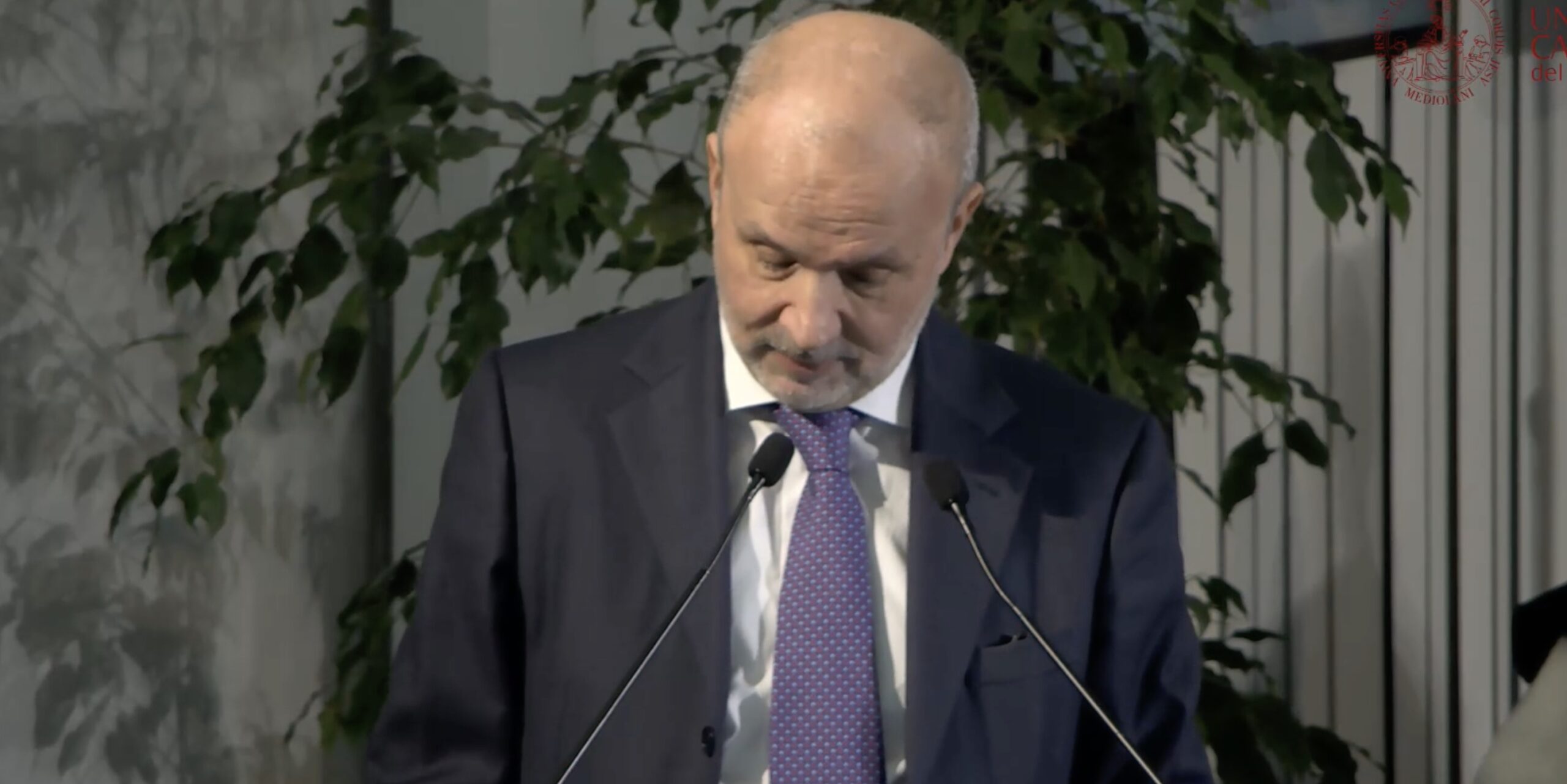Gentile Direttore,
negli ultimi anni il disavanzo sanitario regionale, come ricostruito pochi giorni fa qui su Qs che ha parlato di “profondo rosso” (a proposito, complimenti per la nuova veste grafica), ha smesso di essere un fenomeno tipico di poche realtà “fragili” o occasionale, per diventare un tratto diffuso e ricorrente di sistema. Il 2024 ha rappresentato il punto di massima tensione del’ultimo quadriennio: il saldo negativo supera il miliardo e mezzo prima delle coperture e resta comunque molto elevato anche dopo trasferimenti e compensazioni, segno che i tradizionali meccanismi di aggiustamento non bastano più. Questa situazione ci ha spinto a condividere alcune riflessioni a caldo che articoliamo per punti.
Quando il disavanzo non è più solo “un numero”
La particolarità del quadro attuale sta nel coinvolgimento di quasi tutte le aree del Paese: non sono solo le Regioni storicamente deboli a registrare squilibri, ma anche territori considerati a lungo modelli di efficienza come la Regione Emilia-Romagna. Questo allargamento dell’area del “rosso” indica che la pressione non riguarda solo la qualità della gestione locale, ma anche i vincoli strutturali del finanziamento e dell’organizzazione complessiva dell’assistenza. Con disavanzi così estesi, il rischio non è solo la violazione di un vincolo contabile, ma la progressiva riduzione della capacità programmatoria: Regioni costrette a rincorrere la copertura dell’anno in corso faticano a investire su personale, innovazione e territorio, alimentando un circolo vizioso fra tagli, perdita di qualità e ulteriore ricorso a soluzioni costose a breve termine (vedi i cosiddetti medici “gettonisti”).
Un impatto diretto sulla tenuta dei sistemi sanitari regionali
In questo contesto, il disavanzo diventa un moltiplicatore di disuguaglianze: le Regioni con margini fiscali e assetto strutturali più robusti riescono, almeno in parte, ad assorbire gli shock, mentre quelle più fragili vedono rapidamente peggiorare liste d’attesa, dotazioni tecnologiche e accessibilità dei servizi. I cittadini percepiscono la differenza soprattutto su tre fronti: tempi per visite e interventi, disponibilità di personale e necessità di rivolgersi al privato a pagamento quando il pubblico non risponde. La mobilità sanitaria interregionale accentua queste fratture: le Regioni in maggiore sofferenza perdono sia risorse economiche, attraverso i flussi compensativi, sia credibilità istituzionale, mentre quelle più attrattive vedono aumentare la domanda con un sistema di offerta che deve fare i conti anche con le liste d’attesa. In assenza di una correzione di rotta, il risultato è un Servizio sanitario formalmente nazionale, ma sostanzialmente a geometria variabile con i costi della mobilità attualmente tutti a carico del cittadino: in fondo le Regioni in attivo incassano, quelle in passivo risparmiano sulla produzione, mentre i cittadini sostengono (quando possono) gli enormi costi sociali che la mobilità passiva non di confine (quella prevalente al Sud) comporta.
Le radici: costi che crescono più in fretta delle risposte
Le cause del disavanzo attuale non si riducono a una “mala gestio” regionale: pesano tendenze di lungo periodo spesso sottovalutate. Da un lato, l’invecchiamento della popolazione e l’esplosione della cronicità spingono la domanda di cure, in particolare ospedaliere e farmaceutiche, con ritmi superiori all’aumento delle risorse disponibili. Dall’altro, la stagione dei rinnovi contrattuali, il fabbisogno di nuovo personale e la fine degli espedienti utilizzati negli anni per contenere la spesa di lavoro spingono in alto il costo strutturale del sistema. A questi fattori si aggiunge un utilizzo crescente del privato accreditato: senza un governo attento degli accordi, questo può trasformare un supporto utile in un motore di spesa poco controllato, soprattutto se le attività esternalizzate non sono accompagnate da una riorganizzazione coerente del pubblico. Infine, molti osservatori sottolineano come il livello di finanziamento sanitario nazionale, pur cresciuto nominalmente, non tenga il passo con l’inflazione settoriale e gli standard dei principali Paesi europei, comprimendo i margini operativi delle Regioni (si legga ad esempio qui). Il sottofinanziamento si trascina dietro la crisi nella politica del personale, tema talmente grosso che qui ci limitiamo solo a ricordare.
Oltre le coperture: un’agenda di alternative
Per le Regioni oggi più esposte non è sufficiente puntare su nuove iniezioni di risorse una tantum: serve una combinazione di scelte nazionali e locali che affrontino insieme la causa e non solo il sintomo finanziario. Alcune linee di intervento realistiche e tra loro complementari sono:
- una maggiore coerenza tra bisogni e risorse attraverso ad esempio azioni come: a) la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo sanitario, mettendo più peso su indicatori di cronicità, deprivazione sociale e dispersione territoriale, così da sostenere in modo stabile le Regioni con maggiore fabbisogno strutturale e b) il collegamento di una quota delle risorse aggiuntive cosiddette premiali (che premiali non sono) a obiettivi verificabili (riduzione disavanzo, miglioramento LEA, abbattimento liste d’attesa), con meccanismi trasparenti di monitoraggio e “premio” vero per chi migliora;
- ripensamento dei Piani di rientro che vanno trasformati da strumenti prevalentemente punitivi e burocratizzati orientati verso i soli “adempimenti”, a vere piattaforme di riforma con meno tagli lineari, più supporto tecnico sulla organizzazione dei servizi e maggiore integrazione socio-sanitaria e presa in carico della cronicità. Vanno poi previsti percorsi differenziati: una Regione con deficit causato da shock temporanei ha bisogno di strumenti diversi rispetto a territori con criticità storiche di governance e capacità amministrativa;
- un nuovo governo del rapporto pubblico-privato: vanno rinegoziate le relazioni con il privato accreditato, spostando il baricentro dai volumi erogati agli esiti, alla riduzione delle liste d’attesa e alla copertura di aree dove il pubblico è strutturalmente debole. Va nel settore pubblico evitata la duplicazione di offerta ad alta intensità tecnologica e la frammentazione piccoli poli costosi e sotto utilizzati promuovendo reti interregionali per alcune specialità e concentrando gli investimenti;
- scommettere sul territorio dando piena attuazione alla riforma della sanità territoriale, utilizzando le nuove strutture di prossimità non come “contenitori” ma come nodi funzionali per ridurre accessi impropri in ospedale, ricoveri evitabili e garantire prossimità e continuità delle cure e investendo su prevenzione e presa in carico a lungo termine, anche tramite strumenti digitali e telemedicina, che consentono di contenere costi futuri migliorando stabilmente l’equilibrio tra domanda e offerta;
- un cambiamento nel modo di gestire le organizzazioni rafforzando le capacità gestionali e di controllo nelle aziende sanitarie, passando da un monitoraggio ex post della spesa a sistemi predittivi che permettano di intervenire in anticipo sulle derive di costo, così da generare efficienza nell’organizzazione ed appropriatezza allocativa e puntando su modelli di responsabilità condivisa tra direzioni, professionisti e territori, superando una governance frammentata che spesso scarica il problema finanziario su chi è più vicino al cittadino, ma ha minori leve di intervento;
- una diversa capacità di governo, monitoraggio e controllo da parte del livello centrale: il sistema di monitoraggio dei LEA attraverso gli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia è inadeguato e il sistema di verifica dei processi attraverso il questionario LEA sembra saltato. Si approvano Piani di settore che spingono verso un potenziamento del territorio (alcuni esempi: Piano Nazionale della Cronicità, Piano Nazionale Demenze e Piano Nazionale della Prevenzione), ma contemporaneamente si è abdicato al monitoraggio e controllo delle reti ospedaliere frammentate e disperse, approvando anche programmi di edilizia sanitaria che ne rafforzano queste caratteristiche.
Una crisi che può diventare una scelta di campo
La fotografia dei disavanzi regionali non è, come si ricordava all’inizio, solo un elenco di numeri in rosso: racconta un bivio politico e culturale sul futuro del servizio sanitario pubblico. Continuare con un approccio emergenziale significa accettare una progressiva “normalizzazione” della disuguaglianza nell’accesso alle cure, con Regioni in grado di garantire standard elevati e altre condannate alla rincorsa. Usare questa crisi come leva di riprogettazione, invece, implica invece scegliere consapevolmente di riequilibrare risorse, responsabilità e poteri tra Stato e Regioni, riorientando il sistema verso prevenzione, prossimità e integrazione socio-sanitaria. In questo scenario, il superamento dei disavanzi non è più solo l’obiettivo di “far tornare i conti”, ma il risultato di un patto rinnovato sul diritto alla salute come bene comune, indipendente dal codice di avviamento postale di chi ha bisogno di cura (come ha ricordato anche il Ministro Schillaci).