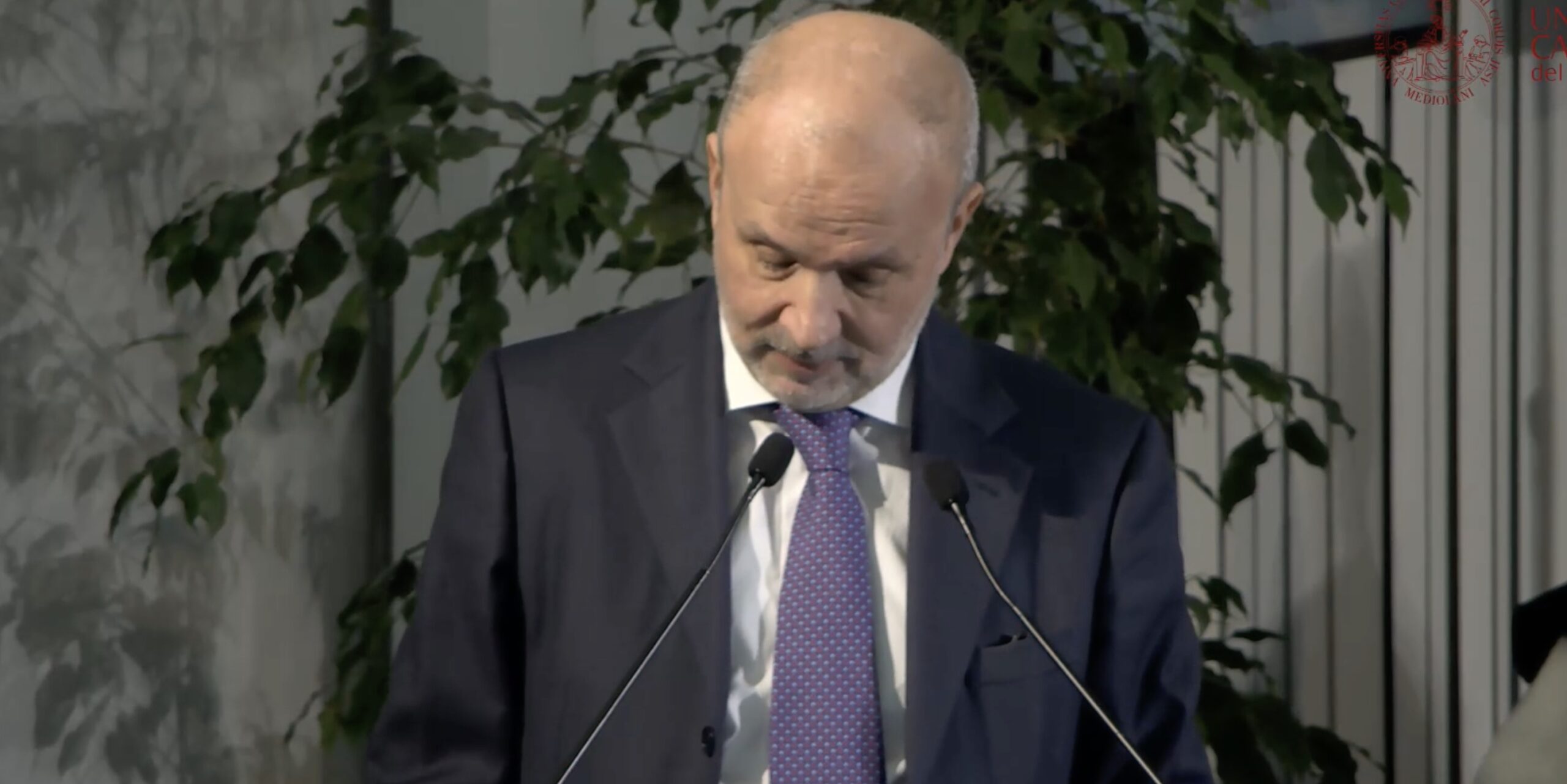Gentile direttore,
quando il 1 marzo 2022 Qs comunicò la composizione del nuovo Consiglio Superiore di Sanità, io rimasi positivamente colpito. Figuravano infatti tra i 30 componenti non di diritto, accanto alle 13 new entries, molte confortanti conferme di personalità da sempre appassionate ai temi della sanità pubblica. Ricordo tra quelle a me più familiari: Paola Di Giulio, vicepresidente e Prof. Associato di Scienze Infermieristiche dell’Università di Torino, Franco Locatelli, presidente e Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica e Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Francesco Longo, Prof. Associato del Dipartimento di Analisi delle Politiche e del Management Pubblico dell’Università Bocconi di Milano, Anna Odone, Ordinario di Igiene Pubblica dell’Università di Pavia, Vito Marco Ranieri, Ordinario di Anestesiologia dell’Università di Bologna, Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della AUSL di Modena e Paolo Vineis, Prof. Ordinario di Epidemiologia Ambientale dell’Imperial College di Londra. Adesso il Consiglio Superiore di Sanità dopo tre anni verrà rinnovato nella sua componente non di diritto ed è il momento buono per fare un primo bilancio e qualche considerazione.
Parto da questa riflessione: molte delle persone che ho nominato hanno pubblicamente e collettivamente testimoniato negli ultimi tempi più volte il loro interesse a partecipare al dibattito sulla crisi del Ssn. Ne sono testimonianza un intervento su Lancet Public health (Tackling the crisis of the Italian National Health Fund) del gennaio 2014, il cosiddetto “Manifesto degli scienziati” pubblicato su Scienza in rete lo scorso aprile 2024, il Documento sui principi per una vera riforma del Ssn presentato lo scorso 29 gennaio a Roma nella sede del CNEL e la recente iniziativa alla Accademia dei Lincei dello scorso 21 febbraio sulla crisi dei sistemi sanitari universalistici . Se però, a fronte di questo impegno pubblico, si cercano nel sito del Ministero della salute dello stesso periodo le pubblicazioni del Consiglio Superiore di Sanità… non se ne trova nessuna. L’ultima risale al 5 settembre 2023 e riguarda una Proposta di regolamentazione per l’appropriatezza dell’utilizzo dei Test Multigenici NGS predittivi e prognostici nella pratica clinica.
Per farmi una ragione di questo silenzio (che rischia di essere scambiato per un silenzio assenso) ho cercato sempre nel sito del Ministero della salute quale sia il ruolo del Consiglio Superiore di Sanità e l’ho trovato così descritto: “Il Consiglio superiore di sanità è organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute. Il Consiglio esprime pareri su richiesta del Ministro e nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in ogni altro caso in cui le Direzioni Generali ne facciano richiesta per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi e nella eventualità che l’Autorità giurisdizionale richieda la consultazione dell’Organo per decidere contenziosi. Il Consiglio svolge anche funzioni consultive propositive.”
A questo punto si aprono diverse possibilità: o il Ministro e le sue Direzioni generali non chiedono pareri, o il Consiglio Superiore di Sanità non li fornisce o il Consiglio li fornisce, ma non vengono pubblicati. Difficile trovare quale delle tre possibili risposte sia la peggiore, ma tendo a immaginare che le più probabili siano la prima e la terza combinate tra loro: mi viene difficile immaginare che personalità come quelle che ho nominato (e altre ancora, ovviamente, che per mia colpa non conosco) si impegnino pubblicamente sia a livello individuale che di gruppi di esperti per testimoniare il loro interesse alla crisi del Ssn e si chiamino poi fuori quando è il Ministro a sollecitarne il coinvolgimento. Pensare che quando escono le pubblicazioni del Consiglio Superiore di Sanità gli elementi di possibile ricaduta sul Ssn sono potenzialmente importanti come ad esempio nel caso del documento, uno degli ultimi usciti, del 6 aprile 2023 sullo Sviluppo organizzativo e gestionale dell’area critica e percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) nel SSN, documento che “vuole offrire ai decisori politici, nazionali e regionali, un’ipotesi degli strumenti organizzativi per una riforma strutturale di tutto il sistema, non legata a momenti emergenziali, al fine di rendere attuabile il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.” Peccato che poi nella bozza del nuovo Piano Pandemico di questo documento io non sia riuscito a trovare traccia.
Sembra strano (almeno a me) che nel nostro Ssn ci sia una sanità centrale che da una parte è tutta sbilanciata ai suoi massimi livelli verso una direzione “universitaria” che dovrebbe essere a forte connotazione scientifica (Ministero, ma anche Istituto Superiore di Sanità e Direzione della Programmazione) e dall’altra il Ministro rinunci al supporto scientifico del suo principale organo di consulenza, e cioè il Consiglio Superiore di Sanità. Il Ministro forse pensa di non averne bisogno, ma il Ssn sanitario ne ha sicuramente bisogno. Temi come il recupero di efficienza attraverso interventi di lotta agli sprechi e alle inefficienze, il contrasto alle diseguaglianze regionali, la politica del personale, il governo della innovazione e degli investimenti e il trasferimento nella pratica dell’approccio One Health sono solo alcuni possibili esempi di temi candidati ad altrettanti pareri e documenti del Consiglio Superiore di Sanità. Se poi non lo si vuole coinvolgere, il Consiglio diventa un organo privo di senso, ma allora non si scomodino nella sua composizione figure autorevoli costrette a un gioco che dall’esterno pare poco onorevole e quindi, conoscendole, inaccettabile.
Claudio Maria Maffei