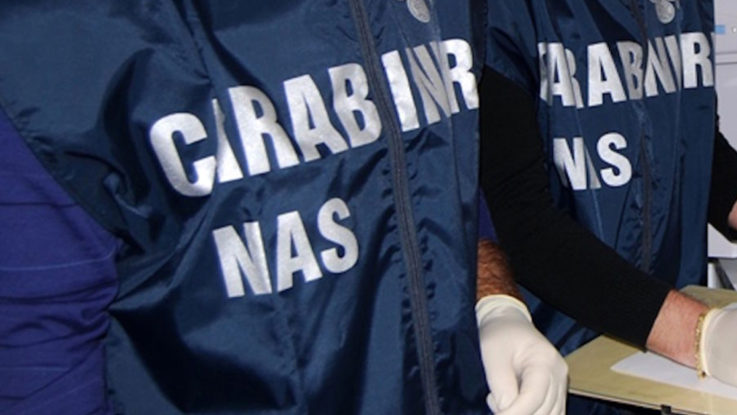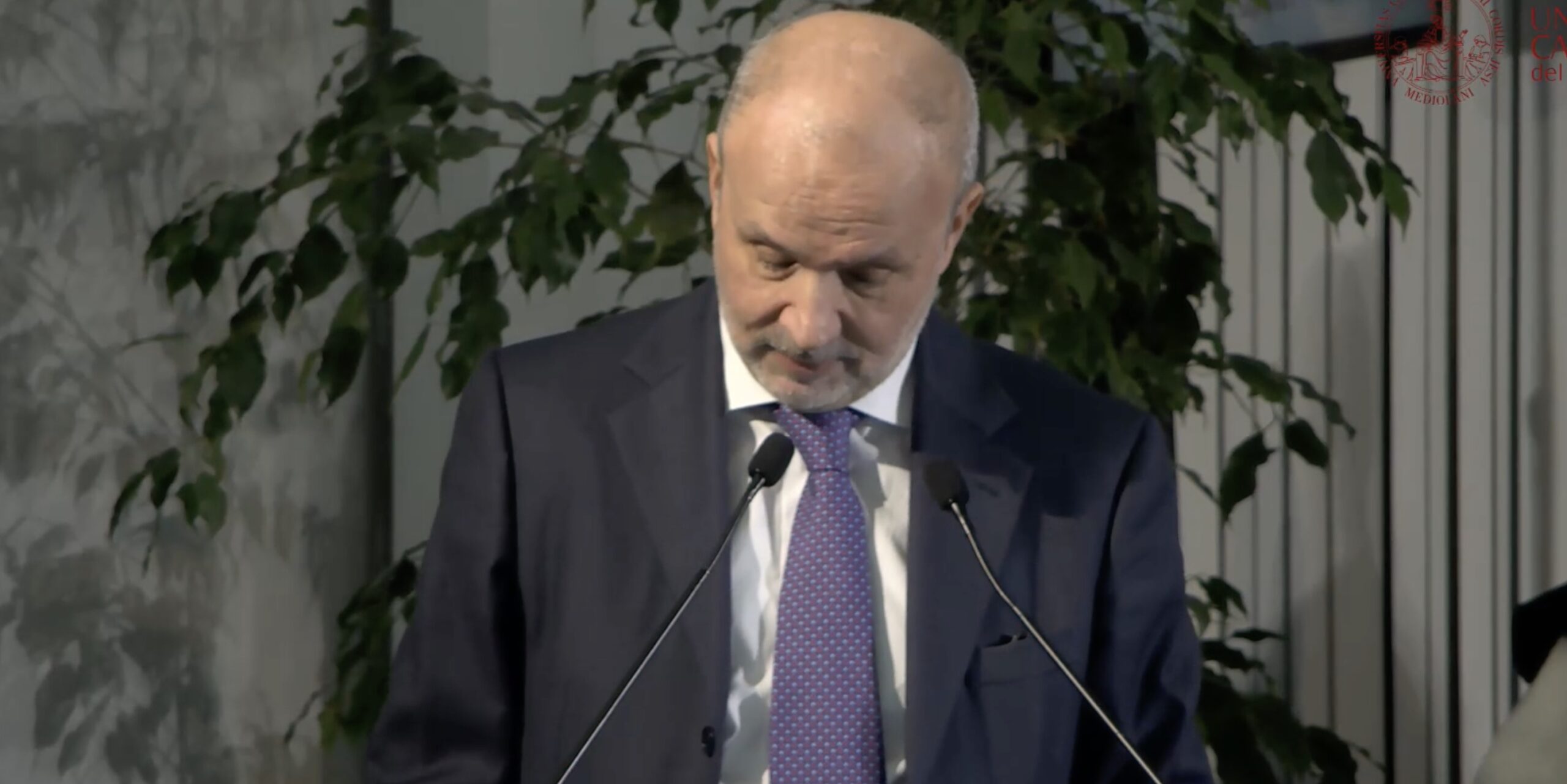È quanto mai attuale e corrispondente ai reali bisogni di salute la recente dichiarazione sottoscritta da 31 Stati Europei con cui si afferma la grave situazione della salute mentale evidenziando che non solo una persona su sei accusa un disturbo ma, soprattutto, una su tre non risposte di cure efficaci e, di conseguenza impegnandosi per far divenire l’obiettivo della tutela e promozione del benessere psicologico in qualsiasi decisione politica in ogni campo di attività della vita civile e dell’organizzazione della società e dello stato.
I numeri che fotografano la situazione nella regione europea dell’OMS sono allarmanti: una persona su sei soffre di un disturbo mentale, ma una su tre tra queste non riceve cure adeguate; la situazione è ancora più critica per chi vive con una psicosi: una persona su quattro non ha accesso ad alcuna forma di trattamento formale. Inoltre, ogni anno, più di 150.000 persone si tolgono la vita, circa 400 ogni giorno: il suicidio è oggi la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; durante la pandemia da COVID-19, la prevalenza di ansia e depressione è cresciuta del 25% su scala globale, aggravando un quadro già complesso.
A questa emergenza si aggiunge una drammatica carenza di operatori della salute mentale, mentre emergono nuovi segnali di disagio, soprattutto tra i più giovani: oltre l’11% degli adolescenti mostra comportamenti problematici legati all’uso dei social media, mentre una ragazza su quattro di 15 anni riferisce di sentirsi sola “la maggior parte del tempo” o “sempre”. Anche tra gli anziani, uno su quattro sopra i 60 anni dichiara di vivere nella solitudine.
Nonostante questo quadro critico, c’è una risposta in costruzione. Il 90% dei 29 paesi coinvolti in una recente indagine dell’OMS ha dichiarato di essere al lavoro su nuove politiche di salute mentale o sull’aggiornamento di quelle esistenti attraverso una nuova e significativa modalità attraverso il necessario superamento di un approccio settoriale e frammentato. La conferenza di Parigi ha infatti riunito, oltre ai ministri della Salute, anche rappresentanti dei settori dell’istruzione, degli affari sociali, della giustizia, dell’edilizia, della cultura e della gioventù, accanto a professionisti, persone con vissuti diretti di malattia mentale, accademici e società civile, facendo emergere emersa la consapevolezza condivisa prevedendo che solo una risposta collettiva, integrata e trasversale potrà affrontare in modo efficace una crisi che riguarda ogni aspetto della vita sociale.
La cosiddetta “Dichiarazione di Parigi” sottolinea la necessità di allineare responsabilità e finanziamenti tra i diversi livelli di governo e settori; coinvolgere le persone con disturbi mentali già nella fase di progettazione delle politiche; creare spazi pubblici che favoriscano l’inclusione e la connessione sociale; sviluppare strategie di prevenzione che partano dalle scuole, dai luoghi di lavoro, dalle carceri, dai media e dai contesti urbani; infine, promuovere un uso sicuro del digitale, in particolare per tutelare i più giovani online. Quindi integrando il benessere psicologico in ogni decisione, in ogni settore, non solo si allevia la sofferenza ma si ridà dignità, speranza e opportunità e quindi la Dichiarazione di Parigi non è solo un testo politico, ma un invito all’azione concreta, prevedendo una nuova architettura delle politiche pubbliche, in cui la salute mentale non sia più relegata ai margini ma riconosciuta come fondamento essenziale per la dignità, il benessere e la coesione sociale; l’’Europa ha lanciato un segnale forte: ora serve una capacità da statista perché ogni Governo trasformi le parole in azioni.
Quindi il benessere psicologico è diventato un tema prioritario per molti stati europei nel contesto di una società in rapido cambiamento: problemi come il crescente stress lavorativo, le disuguaglianze sociali, la pandemia da COVID-19 e l’impatto dei social media devono condizionare i governi affinché mettano in atto politiche mirate a migliorare la salute mentale dei cittadini che non è solo un diritto fondamentale, ma anche uno degli indicatori chiave per valutare la qualità della vita. Infatti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il benessere psicologico è definito come uno stato di benessere in cui l’individuo realizza le proprie capacità, affronta lo stress quotidiano, lavora in modo produttivo e contribuisce alla comunità, per questo il benessere psicologico è strettamente legato al rendimento economico, alla coesione sociale e alla stabilità delle famiglie.
Il benessere psicologico è, quindi, un obiettivo cruciale per gli Stati europei, che stanno investendo in politiche innovative per affrontare sfide sempre più complesse; però l’iter è ancora lungo: la riduzione delle disuguaglianze, la lotta allo stigma e l’adattamento delle strategie ai cambiamenti sociali e tecnologici rimangono priorità assolute; però attraverso un impegno collettivo e collaborativo, l’Europa può e deve aspirare a costruire una società in cui tutti i cittadini possano vivere una vita equilibrata e soddisfacente: questi sono i nuovi valori da realizzare per far riacquisire un ruolo nello scenario mondiale al nostro Continente.
La via italiana al benessere psicologico
Si tratta di analisi e di proposte già affrontate con più contributi anche su questo quotidiano, anche da parte mia e sarebbe quanto mai augurabile che oltre le Regioni, che nella stragrande maggioranza si sono attivate, anche Governo nazionale e Parlamento si attivino in modalità più efficace ed immediate, oltre il bonus psicologico e l’iniziale finanziamento statale per lo psicologo scolastico e soprattutto riprendendo l’iter di approvazione del testo unificato che istituisce il Servizio di psicologia delle cure primarie nelle Aziende sanitarie inspiegabilmente fermo da novembre 2023, nonostante l’acclamata condivisione della sua necessaria e strategica necessità di realizzarlo per contrastare il disagio psicologico, contribuire a promuovere e tutelare il benessere psicologico e per prevenire l’involuzione in patologie psichiatriche, in particolare per le giovani generazioni, se non ora quando questo indispensabile provvedimento legislativo dovrebbe essere approvato?
Non vorrei fare la figura dell’anziano che si ricorda che nelle leggi anticipatrici della riforma sanitaria e nella stesa legge 833/78 la psicologia e il suo campo di azione per la tutela della salute mentale non solo era teorizzato ma anche realizzato, la maggioranza degli psicologi nel SSN furono assunti in quel periodo, perlopiù con contratti di lavoro precari e flessibili, sanati in massa con una legge successiva: mi ricordo che erano oltre 10000 psicologi mentre adesso sono la metà nonostante l’aumento della popolazione e l’individuazione di nuovi bisogni di salute.
Negli anni successivi tra blocco delle assunzioni e processo di aziendalizzazione in sanità, la psicologia e con essa i psicologi subirono una considerevole contrazione sino a che in particolare con la tragedia del COVID19 invece si è realizzata un’inversione di tendenza, ancora non sufficiente nel considerare la psicologia e gli psicologi parte determinate e strategica nella attuazione del diritto alla salute individuale e collettiva, sino, addirittura a considerare il supporto psicologico un diritto esigibile contrattualmente nella recente ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto del personale del SSN. È quindi augurabile che l’Italia avendo sottoscritto che la salute mentale “sia priorità in tutte le politiche pubbliche “nella dichiarazione congiunta di 31 Paesi al termine di una conferenza internazionale tenutasi a Parigi e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute francese, sia coerente con gli impegni presi.
Nella “via italiana” per attuare questa innovativa scelta dell’Europa Regioni e Parlamento hanno individuato nell’istituzione del servizio di psicologia di cure primarie nelle Aziende sanitarie uno dei principali assi portanti per la tutela e la promozione del benessere psicologico nella sanità Infatti, l’estensione delle esperienze in atto in molte Regioni ha concretizzato il ruolo dello psicologo di cure primarie sempre più essenziale nel SSN riconoscendo l’importanza della salute mentale come parte integrante del benessere complessivo, operando direttamente negli ambiti delle cure primarie, affiancando medici di famiglia e altri professionisti della salute assicurando supporto psicologico tempestivo e accessibile e garantendo interventi brevi e mirati, focalizzati sul trattamento di disturbi comuni come ansia, depressione, stress e difficoltà di adattamento. In una società in cui il ritmo della vita è sempre più veloce e le esigenze personali e professionali sono in costante aumento, il supporto psicologico nelle cure primarie è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane; per questo lo psicologo di cure primarie permette di: intervenire precocemente nei disturbi psicologici, evitando che si aggravino, ridurre il carico sui servizi di salute mentale specialistici e fornire supporto emotivo e pratico per gestire situazioni di vita difficili.
Pertanto, lo psicologo di cure primarie è formato per affrontare una vasta gamma di problematiche, includendo le principali aree di intervento: disturbi d’ansia e del tono dell’umore, problemi legati allo stress, sia acuto che cronico, difficoltà relazionali o familiari, sostegno psicologico per malattie croniche o condizioni fisiche che influenzano la salute mentale, educazione alla gestione delle emozioni e al miglioramento della resilienza. Lo psicologo di cure primarie, ove realizzato, garantisce: facilità di accesso: essendo integrato nei servizi di cure primarie, i pazienti possono ricevere supporto senza lunghi tempi di attesa; riduzione dello stigma in quanto l’accesso diretto o attraverso il medico di base normalizza il ricorso al supporto psicologico; approccio preventivo intervenendo precocemente riducendo gli effetti a lungo termine dei disturbi mentali. Per questi motivi lo psicologo di cure primarie rappresenta una svolta fondamentale nel modo in cui le persone accedono al supporto psicologico e attraverso la sua presenza nei servizi di cure primarie, può garantire un intervento tempestivo, efficace e accessibile a un numero sempre maggiore di persone migliorandone la qualità della vita.
Ne consegue che tenuto conto di quanto sopra e del fatto che undici Regioni abbiano già legiferato in materia, finanziando con fondi propri e realizzando i primi servizi di psicologia delle cure primarie, con gradimento non solo di chi a loro si rivolge ma anche degli altri medici e professionisti della salute, per questa determinante collaborazione e integrazione, sarebbe quanto mai opportuno anzi dovuto che riprenda l’iter di approvazione del testo unificato sullo psicologo delle Cure primarie in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, prevedendo il necessario finanziamento statale oltre quello già in essere delle Regioni.
Considerata la convergenza unanime sui contenuti della proposta di legge sarebbe quanto mai auspicabile che venga approvata in sede deliberante già in Commissione: sarebbe un’ulteriore risposta di una buona politica che considera la salute un bene universale; certamente questa legge non costituirebbe l’unica risposta al potenziamento e all’implementazione dell’intervento della psicologia in sanità come in ogni attività pubblica ma già iniziare dalla sua approvazione e realizzazione si potrebbe compiere un’importante e storico progresso normativo, organizzativo e, perché no, scientifico, nelle politiche di promozione e tutela della salute.
Saverio Proia