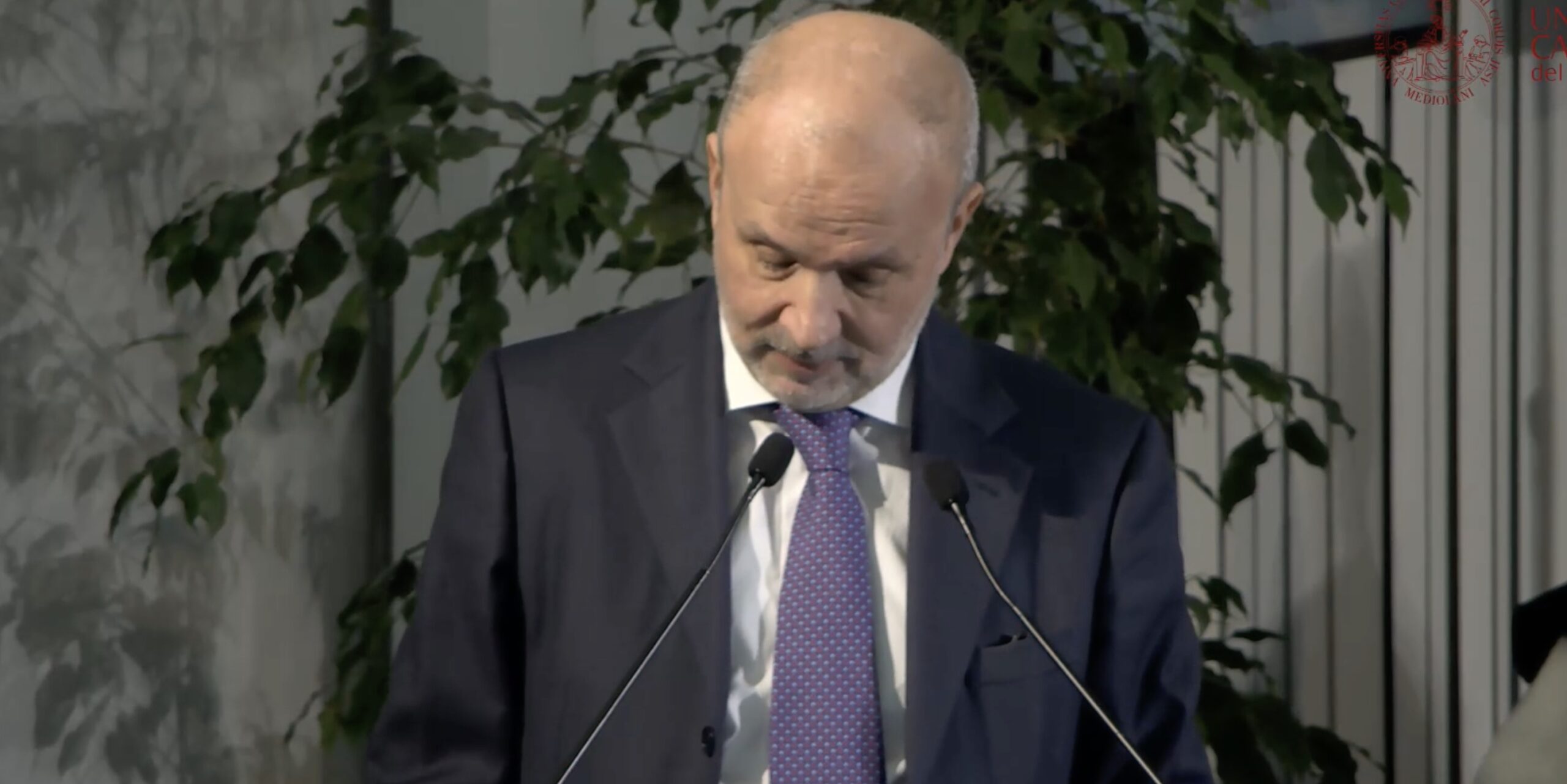Ministro Sacconi, come lei ha più volte ribadito, promuovere la salute consente di ridurre la povertà, l’emarginazione e il disagio sociale e anche di incrementare la produttività del lavoro, i tassi di occupazione, la crescita complessiva della economia. In questo quadro quanto è importante avere un servizio sanitario che sia universale e quindi garantisca a tutti la tutela della salute?
Naturalmente un sistema sanitario universale ed efficiente è uno dei principali diritti di ogni cittadino. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera quello italiano uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, sia per quanto riguarda il miglioramento dello stato di salute della popolazione che per quanto riguarda la risposta alle aspettative di assistenza e di cura dei cittadini. Purtroppo, però, esistono sul nostro territorio enormi disparità e situazioni di estrema inefficienza dovute, più che alla mancanza di mezzi, ad un differente impiego delle risorse. Solo la metà del Paese offre servizi sanitari di buon livello, presentando spesso situazioni di eccellenza, mentre l’altra metà, in particolare il Centro-Sud, spende di più e garantisce di meno, condannando i cittadini a muoversi da una regione all’altra alla ricerca di un servizio migliore.
Se fra le prime azioni del Governo ci sono state il commissariamento del sistema sanitario di alcune regioni e i piani di rientro – che hanno determinato un netto cambiamento di rotta nella gestione della qualità del servizio – oggi ritengo che, per raggiungere l’obiettivo di arrivare in tempi brevi a una radicale riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, sia indispensabile portare a compimento la riforma istituzionale del federalismo fiscale, con l’introduzione dei costi standard per la sanità, estremamente significativa per valorizzare compiutamente la dimensione del territorio e, in ciascun territorio, la responsabilità degli amministratori locali, soprattutto nel Mezzogiorno.
Questo nell’ottica di un sistema di Welfare tutt’altro che rinunciatario rispetto alle esigenze di universalità e nella consapevolezza della necessità di assicurare uguaglianza di trattamento, in particolare verso i meno abbienti. Non il razionamento delle prestazioni, quindi, quanto piuttosto la loro appropriatezza, riducendo allo stesso tempo la dinamica della spesa sanitaria, per evitare che cresca secondo tendenze che ne fanno prevedere il raddoppio entro il 2050.
Il Presidente degli Stati Uniti Obama ha scelto di andare in questa direzione. Quanto è importante per una democrazia promuovere un modello sociale orientato a promuovere l’autosufficienza di ciascuna persona, di tutte le persone?
Gli Stati Uniti si sono trovati ad affrontare quella che per lungo tempo è stata considerata una vera e propria piaga sociale: un sistema, cioè, che non garantiva la copertura sanitaria per molta parte della popolazione e che, dal punto di vista della qualità delle cure mediche offerte, vedeva il paese molto più indietro rispetto ad altri dall’economia altrettanto avanzata. Vorrei sottolineare, però, che se da un lato – secondo i criteri che hanno ispirato la riforma del sistema sanitario di Obama – è fondamentale poter contare su un sistema sanitario in grado di tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino, dall’altra è importante non sottostare ad una logica, come è accaduto per anni in Italia, di eccessivo paternalismo.
Le criticità del nostro sistema, infatti, hanno dimostrato che non è più possibile, né utile, distribuire beni e servizi in forma meramente assistenziale ed indifferenziata, ma sarebbe invece necessario individuare singoli bisogni e modalità appropriate per rispondervi, se non addirittura intervenire in anticipo rispetto al formarsi del bisogno con una offerta personalizzata. La salute, infatti, non si identifica più unicamente con la cura della malattia ma, soprattutto con la promozione del benessere e lo sviluppo delle capacità personali, tenendo conto delle differenti condizioni di ciascuno. Un cambiamento di prospettiva importante, quindi, che incide sui modelli di organizzazione e punta alla promozione di corretti stili di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente di vita e di lavoro.
Questo è il presupposto alla base del nuovo Welfare delle opportunità e delle responsabilità, dove, a fianco della “presa in carico” della persona in ogni fase della sua vita – dalla tutela della vita, dal concepimento alla sua fine naturale, alla salute in senso più lato fino all’aspetto educativo, dalla fase di transizione dalla scuola al lavoro al lavoro stesso, alla pensione – ad essere stimolati sono anche i comportamenti responsabili, e per questo utili a sé e utili agli altri.
Lei ha scritto nel Libro bianco che il primo valore che ci deve guidare è la centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali. Cosa manca ancora in Italia per realizzare un vero Welfare delle opportunità e delle responsabilità?
Per concretizzare quella che definirei una vera e propria rivoluzione, anche culturale, dobbiamo ulteriormente investire sulle tante potenzialità delle persone e della nostra comunità nazionale, promuovendo, allo stesso tempo, un nuovo assetto della presenza pubblica nell’economia e nella società: una visione che sintetizzo nel concetto di “meno Stato, più società”. Una visione, cioè, che da una parte vuol dire ridurre l’invasività dell’intermediazione dello Stato e delle sue strutture e, dall’altra, produrre un sostanziale spostamento dal pubblico verso la persona, le famiglie, le forme associative che le persone e le famiglie sanno produrre, soprattutto in un paese come il nostro, nel quale esiste una straordinaria tradizione in questo senso.
Centralità della persona, quindi, ma anche attenzione alle politiche di prossimità e di sussidiarietà, che trovano nel territorio l’ambito più idoneo per la loro realizzazione, un ambito in cui le istituzioni, il Terzo Settore, le associazioni rappresentative del mondo del lavoro possono integrarsi in modo efficiente e costruire soluzioni efficaci sia per quanto riguarda lo sviluppo locale che la giustizia sociale: dalle politiche attive rivolte a garantire la continua occupabilità e rendere effettivi i diritti fondamentali del lavoro fino a quelle relative ai servizi socio-sanitari rivolti alla prevenzione, alle cure primarie, all’assistenza domiciliare. Dai servizi di cura per sostenere la natalità alle azioni personalizzate per contrastare la povertà, fino alle politiche per promuovere l’integrazione della immigrazione.
In un contesto di questo tipo, in cui la sussidiarietà orizzontale si incrocia con quella verticale, ogni cittadino ha maggiori possibilità di diventare soggetto attivo, protagonista di un percorso in cui, a fianco delle tutele e dei sussidi garantiti dalle istituzioni nazionali e locali, può potenziare le proprie capacità di rispondere al bisogno, costruendo reti sociali, sfruttando le opportunità e gli stimoli e, allo stesso tempo, vivendo in maniera responsabile la propria libertà, una “vita buona nella società attiva”.
L’attenzione ai meriti e ai bisogni delle persone potrà consentire di meglio coniugare le esigenze della sostenibilità con quelle della equità?
Sono convinto che una maggiore attenzione ai meriti delle persone, da una parte, e ai loro bisogni, dall’altra, rappresenti l’importante presupposto per coniugare al meglio le esigenze di sostenibilità con quelle di equità, anche perché le nuove politiche per lo sviluppo sociale non solo potranno consentire una più equa distribuzione della ricchezza, ma stimoleranno allo stesso tempo la crescita dell’economia, grazie alla loro capacità di produrre nuovi lavori, di ridurre il bisogno, di alimentare la qualità del nostro capitale umano e di agevolare la mobilità sociale.
Le politiche in atto, però, non potranno esulare dal necessario confronto con la ricchezza disponibile e con il debito pubblico che il Paese ha accumulato. La stessa crisi che ci siamo trovati ad affrontare, peraltro, ci ha posto ancora di più di fronte all’evidenza che oggi non possiamo più disporre di ingenti iniezioni di finanza pubblica nell’economia e che è giunto il momento di fare i conti con il problema della sostenibilità.
In questa legislatura, grazie ad una seria disciplina di bilancio, siamo riusciti a contenere il debito ma siamo consapevoli che per il percorso di rinnovamento del sistema sociale italiano non potrà non passare attraverso un nuovo presupposto finanziario e fiscale, basato inevitabilmente su condizioni straordinariamente nuove della produzione, dell’organizzazione e della distribuzione della ricchezza, oltre che su un cambiamento, necessario e improrogabile, del presupposto culturale.
Un nuovo Patto Sociale, quindi, fondato sulla razionalizzazione del settore pubblico e sulla sua capacità di dialogare con il settore privato, ma anche su un nuovo paradigma di pensiero, l’antropologia positiva, che chiama tutti noi a restituire fiducia alla persona ed alla sua innata attitudine a potenziare l’autonoma capacità dell’altro.
Teresa Bonacci
Direttore responsabile "Il Welfare d'Italia"